Lavinia Spalanca
Camillo Sbarbaro poeta e scienziato






Sommario
|
I. II. III. IV. |
Il «cacciatore di farfalle» Tra passione estetica e indagine scientifica Un collezionista imperfetto Immagini |
|
Matematica: un mondo che l'uomo si è fabbricato per respirare almeno lì certezza; la sua terraferma, non importa se anch'essa illusoria. C. Sbarbaro, Fuochi fatui |

I. Il «cacciatore di farfalle»
In una delle tante boîtes à surprise inviate all'amico Fausto Saccorotti, appassionato come lui di botanica, Camillo Sbarbaro si definisce emblematicamente un cacciatore di farfalle: «Per esortarlo alla caccia grossa spedisce Sbarbaro, cacciatore di farfalle al moderno Nembrotte Saccorotti Signor Fausto cacciatore di scriccioli».1 Cacciatore di farfalle equivale, nell'allusivo gergo sbarbariano, a collezionista di licheni, ossia le minime forme di vita vegetale da lui raccolte e amorosamente messe in serbo per oltre trent'anni.2 S'intravede così, dalle parole dell'autore, un'affinità elettiva fra la farfalla e il lichene, originata dalla compresenza, in entrambe le creature, di fragilità e iridescenza. Non è un caso che l'aggettivo «versicolori» sia impiegato dal Nostro per esaltare i fantasiosi cromatismi dei lepidotteri - «Al buio, fiori sbocciarono: mai visti, simili a rettili; brillanti come di vetro; pagliettati d'oro; su cui farfalle versicolori esitavano» - e le altrettanto fantastiche colorazioni dei licheni - «Né mancano licheni bicolori, tricolori; [...]; licheni fulgenti, rutilanti e persino versicolori...».3 L'«estroso fanciullo» che «piega versicolori carte», secondo la celebre immagine montaliana,4 tende dunque ad accomunare la farfalla al lichene in virtù dell'allegria dei colori, ma sotterraneamente intravede un ulteriore legame, che risiede nel loro «modo attutito di esistere». È vero che il vegetale si distingue per un'insospettabile prepotenza di vita, tanto da divenire oggetto d'identificazione per il poeta, ma è anche vero che non vi è nulla di più inconsistente di questa entità naturale. Chi «vive nell'attimo» - e ne è profondamente consapevole come Sbarbaro - non può che inseguire volubili farfalle o cogliere effervescenti licheni, secondo un'opzione etico-poetica che risente anzitutto della lezione pascoliana. Come l'autore di Myricae, anche il Nostro va alla ricerca della natura più umile e negletta, esibendo il suo distacco da certi moniti di ascendenza carducciana. Se l'autore delle Odi barbare sentenziava infatti: «Non curïoso a te de le cose piccole io vengo: / chi le farfalle cerca sotto l'arco di Tito?»,5 il poeta ligure, con evidente rovesciamento parodico, scrive di sé nel '32: «per me che sotto l'arco di Tito cerco le farfalle, quel che conta è il colore del mare».6 L'immagine metaforica del lepidottero rimanda dunque alla scelta programmatica di un fragile microcosmo, incarnata appunto dall'universo in sordina del lichene, che solo lo sguardo amoroso e attento del poeta può cogliere nella sua vera essenza: «gli incospicui e negletti licheni, a salutarli a vista per nome, pare di aiutarli ad esistere».7 È possibile scorgere, quindi, alcune singolari corrispondenze fra la farfalla e il lichene; e da una rapsodica disamina dell'opera sbarbariana è agevole inoltre individuare la funzione che essi assumono nel suo immaginario poetico.
Sin dall'esordio lirico di Resine, Sbarbaro identifica nell'allegra creatura alata l'essenza mutevole e leggera del cosmo, in una parola, l'anima infantile della natura, quell'«anima dolce di bambino [che] non puoi neanche un attimo afferrarla».8 Nel bambino che insegue le farfalle è da intravedere dunque l'immagine metaforica dell'artista. In un altro componimento giovanile, Cimitero di campagna, il lepidottero assume invece un'ulteriore valenza: «Qui m'è facile pensare / che questa farfalletta che qui alia, / un giorno morta si trasformerà / nel geranio fiammante del balcone / o nei capelli d'una donna amata...».9 Se da una parte è ribadito il senso dell'effimero connaturato alla farfalla, dall'altra si profila la possibilità di una rinascita eterna sotto nuove parvenze (il «geranio fiammante del balcone»; i «capelli d'una donna amata»). E qui si colgono, su un sostrato lirico pascoliano, evidenti suggestioni gozzaniane: «E intorno declina l'estate. / E sopra un geranio vermiglio, / fremendo le ali caudate / si libra un enorme Papilio...», scriveva il poeta crepuscolare ne L'assenza.10 L'enigmatica Papilio, al centro della lirica di Gozzano, svolge però ben altra funzione dell'innocua «farfalletta» sbarbariana. Come osserva al riguardo Renato Aymone, in tutta la sua entomologia poetica l'autore dei Colloqui attribuisce alla farfalla il ruolo di portanovelle, sia nella variante sinistra, turbatrice e demoniaca della «cupa messaggera funeraria», che in quella esorcistica, rassicurante, edenica del talismano volante.11 Nunzio «di tenebre e di morte», approdato a noi mortali da regni oltremondani, il simbolo crepuscolare è circonfuso di un'aura di mistero. Emblema di leggerezza ed elevazione, quasi un contravveleno alla pesantezza del vivere, la farfalla di Sbarbaro è assimilabile invece a tutte le presenze vegetali, dal «fil d'erba» al lichene, la cui beata contemplazione innesca nell'autore una promessa di redenzione, di liberazione dalla propria miseria esistenziale.12


II. Tra passione estetica e indagine scientifica
Fragile e iridata creatura, la farfalla è destinata a veicolare un'opposta esigenza da parte del poeta ligure: di consistenza e durata («questa farfalletta che qui alia, / un giorno morta si trasformerà / nel geranio fiammante del balcone / o nei capelli d'una donna amata») e di liberazione dalla pena del vivere. Questa duplice aspirazione, alla permanenza e alla provvisorietà, è reiterata da Sbarbaro in una successiva prosa di Liquidazione: «Oh poter essere eterna e farfalla insieme»!13 La tensione dialettica fra coscienza dell'effimero e necessità di resistere alla dispersione, e dunque fra precarietà e tenacia dell'esistenza, contraddistingue lo stesso lichene: l'effervescenza del vegetale, quella evanescenza che lo rende pari alla nuvola o alla bolla di sapone, convive infatti con la straordinaria prepotenza di vita, perfetta incarnazione dell'artista che oscilla perennemente fra un modo spoglio di esistere e una disperata vitalità. È proprio in virtù della sua lucida consapevolezza di ciò che è fugace che Sbarbaro si aggrappa all'elemento naturale. Non solo. Il poeta avverte la necessità di attribuire consistenza alle minime manifestazioni del mondo fenomenico. Da qui il bisogno di siglare, mediante la potenza evocatrice della parola poetica, o l'esattezza nominale della definizione scientifica, la più negletta presenza naturale. Viceversa per Gozzano, che nella farfalla intravedeva l'emblema dell'«esile sopravvivenza» dell'arte, tanto che le sue stesse epistole entomologiche sono da considerarsi - come osserva Bárberi Squarotti - una radicale «testimonianza di fine della poesia»,14 non sussisteva alcuna possibilità, magari illusoria, di attribuire una vita più piena attraverso la parola. La sfiducia nel segno, che si declina nell'eleganza fine a se stessa del poema Le farfalle, investiva l'immagine stessa del lepidottero, simbolo di morte, altresì giustificando la diffidenza dell'autore nei confronti di qualsivoglia tentativo di determinazione tecnica. Pur facendo uso di aggettivi, sostantivi ed espressioni del gergo scientifico, il poeta crepuscolare non riusciva infatti a fondere la precisione terminologica dell'entomologo con l'indefinitezza evocatrice dell'artista. È sufficiente considerare Le farfalle per avvedersi della letterarietà dell'operazione, testimoniata dalla ripresa programmatica del poemetto didascalico settecentesco:
«Come dal germe ai suoi perfetti giorni
giunga una schiera di Vanesse; quali
speranze buone e quali fantasie
la creatura per volar su nata
susciti in cuore di colui che sogna
col suo lento mutare e trasmutare,
la meraviglia delle opposte maschere,
la varia grazia delle varie specie,
in versi canterò... Non vi par egli,
non vi par egli d'essere in Arcadia?».15
L'iperletterarietà del componimento è attestata dal richiamo insistito a memorie poetiche e filosofiche, da Dante a Mascheroni a Maeterlinck. Ecco perché Gozzano, nelle successive Lettere dall'India, manifesta un netto rifiuto della nomenclatura botanica: la classificazione scientifica, a suo giudizio, rende prosaica e farmaceutica la poesia della natura:
Viceversa Sbarbaro, pur non condividendo il rigore tassonomico di certe sterili classificazioni, non disdegna di rifarsi all'esattezza del linguaggio tecnico, alla limpidezza delle sue nitide determinazioni, a riscattare l'evanescenza della natura:«I magnifici scenari verdi del Vittoria Garden, delle ville dell'Esplanade, e del Malabar-Hill sono meditati da giardinieri esperti su modelli inglesi, e ogni albero reca sul tronco una targa ovale col nome in corretto latino: Cinnamomum camphora, Vanilla aromatica, Ficus elastica, Strychnos nux vomica, Tamarindus indica, ecc., ecc., pessima consuetudine che dà alla poesia d'un giardino esotico un sentore farmaceutico e tutta la prosa d'una rivendita di droghe e coloniali».16
«Anche la nomenclatura botanica, spesso balorda e nel suo latino barbarica, ha delle parole evocative. Populus tremula: tremulo non mette il pioppo sott'occhio meglio di qualunque descrizione?».17
È sufficiente, del resto, scorrere i sei inventari lichenologici da lui redatti nel corso della sua esistenza, per accertarsi dell'impiego di un formulario tecnico privo di qualunque orpello estetizzante o astrattizzante, com'è possibile rinvenire ancora negli scritti gozzaniani. Nella premessa alla sua prima pubblicazione scientifica, il Contributo alla flora lichenologica ligure (F. 1), il poeta di Pianissimo cita infatti due importanti trattati di botanica, il «Catalogus Lichenum Universalis» di Alexander Zahlbruckner, e l'«Enumerazione dei Licheni di Liguria» di Francesco Baglietto.18 L'impiego di locuzioni epigrafiche quali «Muricola»; «Rupicola»; «Lignicola», usate ad esempio nell'inventario del '41 Lichenes ligustici novi vel rariores (F. 2), è spia della sua profonda conoscenza di quelle formule sintetiche, come «saxicola» e «corticola», caratteristiche del Catalogus di Zahlbruckner e di numerosi altri trattati scientifici.19 Non solo. Alcuni inventari sbarbariani costituiranno la fonte per gli stessi botanici, e si pensi allo scienziato svedese Rolf Santesson, che negli anni '50 elaborerà una revisione della tassonomia lichenologica grazie agli studi dell'autore ligure.20 Se diventa un punto di riferimento per gli stessi esperti, Sbarbaro mostra altresì di avere introiettato la sobrietà del linguaggio scientifico. Dalla lettura dei suoi ultimi contributi trapela infatti il progressivo prosciugamento della sintassi, la diagnosi sempre più stringata del vegetale, in linea con lo stile rigoroso dei compendi di botanica. E basti considerare, al riguardo, le classificazioni contenute nel suo ultimo elenco, Aliae lichenum species in Italia (praesertim in Liguria) inventae (F. 3): «Verrucaria acrotelloides Mass. Genuae, in valle Bisagno. Verrucaria cinereolimbata Serv. Siena, Loco Monteliscai. Verrucaria Eggerthii Stnr. In Sicilia: Taormina».21


III. Un collezionista imperfetto
Da questo rapido excursus emerge quindi, con sufficiente evidenza, la scrupolosa attenzione sbarbariana nei confronti dell'esattezza classificatoria del linguaggio tecnico. Se condivide con Gozzano l'interesse per la natura, la necessità d'indagarne l'essenza,22 il rigore dello spirito analitico funge per l'autore ligure da antidoto ad ogni facile tentazione estetizzante. La scienza è per lui sinonimo di misura, disciplina interiore, possibilità, magari illusoria, di razionalizzare il Caos dell'esistenza: «Matematica: un mondo che l'uomo si è fabbricato per respirare almeno lì certezza; la sua terraferma, non importa se anch'essa illusoria».23 La creazione dell'erbario assume inoltre una funzione risarcitiva. Fino all'ultimo il poeta ligure identifica nella collezione lichenologica il miglior viatico per ritrovare l'innocenza perduta ed esorcizzare, così, la minaccia del vuoto. Perduto per il mondo, riconquista il suo mondo partecipando meravigliato della bellezza del cosmo, elevandosi quasi al di sopra della condizione mortale. Al punto che in un passaggio di Vita e miracoli dei licheni del '42, abbandonandosi ad una rêverie «quasi scientifica», paragona i suoi voli pindarici da un lichene all'altro agli svolazzamenti di fiore in fiore della farfalla:
«Quando un luogo mi piace troppo perché vagheggiarlo con gli occhi mi appaghi, a illudere l'impossibile voglia d'una maggiore comunione con esso, mi soccorre una fantasia quasi scientifica: un aerostato in cambio di ali, che compensi il peso del corpo; farmi lieve per esso, come si dice saremmo nell'atmosfera della luna. Dietro la voglia e il capriccio, sorvolare quel luogo; della mano sfiorare l'oliveto quasi dorso di gregge; tuffarmi in un verde, calarmi dove un'acqua canta; aggallare d'un balzo a quel greppo; incuriosirmi del bianco che trema su quel precipizio; andare e tornare, esser qui ed esser là: piluccare quel luogo come un grappolo d'uva, a gara con la farfalla che deliba il suo prato di fiori».24
Il cacciatore di farfalle si è reincarnato, affrancandosi dalla pena del vivere, nella «farfalla che deliba il suo prato di fiori», emblema della leggerezza finalmente acquisita, coincidente col recupero della sua anima fanciullesca. Quella stessa aspirazione alla leggerezza, manifestata nei primi componimenti poetici dell'autore, si è adesso concretizzata attraverso la passione botanica, come si evince pure dall'accorato congedo del '62 Addio ai licheni. Se in Gozzano mai «la Morte s'ebbe / più delicato simbolo di Psiche: / psiche ad un tempo anima e farfalla», dove anima è sinonimo di morte,25 viceversa in Sbarbaro il lichene è garanzia di un ritorno alla vita:
«Benvenuto amore che della mia vita (vista almeno in riepilogo) ha fatto una quasi continua ricreazione, se appena fuori d'un abitato, torno, alla mia età!, il fanciullo ammesso a far man bassa in un emporio di giocattoli».26
La fanciullezza è recuperata idealmente nella dialettica fra particolare e universale, infinitamente piccolo e infinitamente grande. Avvalendosi degli strumenti dello scienziato quale incentivo alla sua facoltà immaginativa - si pensi alla lente del botanico - l'artista scopre le potenzialità espressive del lichene.27 Le morbide venature del vegetale, ingrandite dall'occhio artificiale, diventano paesaggi lunari, che schiudono alla vista potenziata del soggetto le infinite meraviglie del possibile. È scoprire che oltre il deserto, cui l'arido e disseccato lichene inevitabilmente rimanda, si cela un mondo nuovo e inesplorato, l'eden del naturalista che viaggia, ore ed ore d'intensa solitudine, in spazi interminati di una bellezza siderale. È anche vero però che il poeta, fedele alla costante oscillazione fra eterno ed effimero che da sempre lo caratterizza, non dimentica che il vegetale racchiude «il senso della provvisorietà» del vivere:
«Finalmente! Leggo in un libro - l'ultimo uscito sulla controversa questione - che il lichene non è una crittogama né l'associazione di due, ma solo un conflitto: un fenomeno, dunque - e di distruzione; paragonabile a quello di due sostanze che venute a contatto si elidono. Capisco, adesso, perché questa passione ha attecchito in me così durevolmente: rispondeva a ciò che ho di più vivo, il senso della provvisorietà. Sicché, per buona parte della vita, avrei raccolto, dato nome, amorosamente messo in serbo... neppure delle nuvole o delle bolle di sapone - che per un poeta sarebbe già bello; ma qualcosa di più inconsistente ancora: delle effervescenze, appunto. Saluto con trasporto la nuova interpretazione e l'abbraccio: nessun bilancio a trent'anni di ricerche andrebbe più a genio a chi vive nell'attimo».28
La perenne tensione dialettica fra tenacia e precarietà dell'esistenza contraddistingue proprio l'indole collezionistica dell'autore: da collezionista il poeta intraprende una strenua lotta contro la frammentarietà ricreando, nello spazio dell'erbario, una catena simbolica in cui è riunito tutto ciò che è affine. Ciò non toglie che in ogni collezionista, come insegna Benjamin, si nasconda un allegorista:
«In ogni collezionista si nasconde un allegorista e viceversa. Per quanto riguarda il collezionista, la sua collezione non è pur mai completa, e quando gli mancasse anche un solo pezzo, tutto ciò che ha raccolto resterebbe pur sempre incompiuto, ciò che appunto le cose sono per l'allegorista fin dal primo momento. D'altra parte proprio l'allegorista - per il quale le cose rappresentano sempre solo le voci di un dizionario segreto che tradirà all'esperto i loro significati - non disporrà mai a sufficienza di quelle cose che gli occorrono: che siano cioè tanto meno sostituibili l'una all'altra, quanto più resta vietato a ogni possibile riflessione prevedere quel significato che la sua assorta profondità potrà rivendicare per ciascuna di loro».29
Raccogliere, dare nome, amorosamente mettere in serbo le più umili creature non rimuove, dunque, la coscienza della precarietà, frantumazione e dispersione consustanziali al vivere. L'ancorarsi alla natura, da collezionista-allegorista, non neutralizza la consapevolezza del nulla che si cela dentro la sottile tela fenomenica. Ed è per questo che Sbarbaro si appaga di ciò che è visibile, proprio perché intuisce l'estrema labilità del mondo, il suo sbriciolarsi e ripiombare nel vuoto, come già confessava al «cacciatore di scriccioli» Fausto Saccorotti: «Fortunati allora quelli che all'apparenza di qualchecosa si fermano, paghi, senza toccare il nulla che cela».30 Se lo stesso lichene si caratterizza per una profonda inconsistenza, ecco che si riconferma l'analogia iniziale con la farfalla: non nella luttuosa accezione gozzaniana, ovviamente, ma come esile spoglia fra il tutto e il nulla. Chi raccoglie e conserva le più evanescenti creature compie però l'unico gesto veramente nobile, giacché tenta di conferire un'«immortalità», per quanto provvisoria e precaria, a ciò che è destinato immancabilmente a svanire: «"Che fai, poeta, lì tutt'occhi e zitto?" "Chiappo farfalle, sola consistenza"».31


IV. Immagini
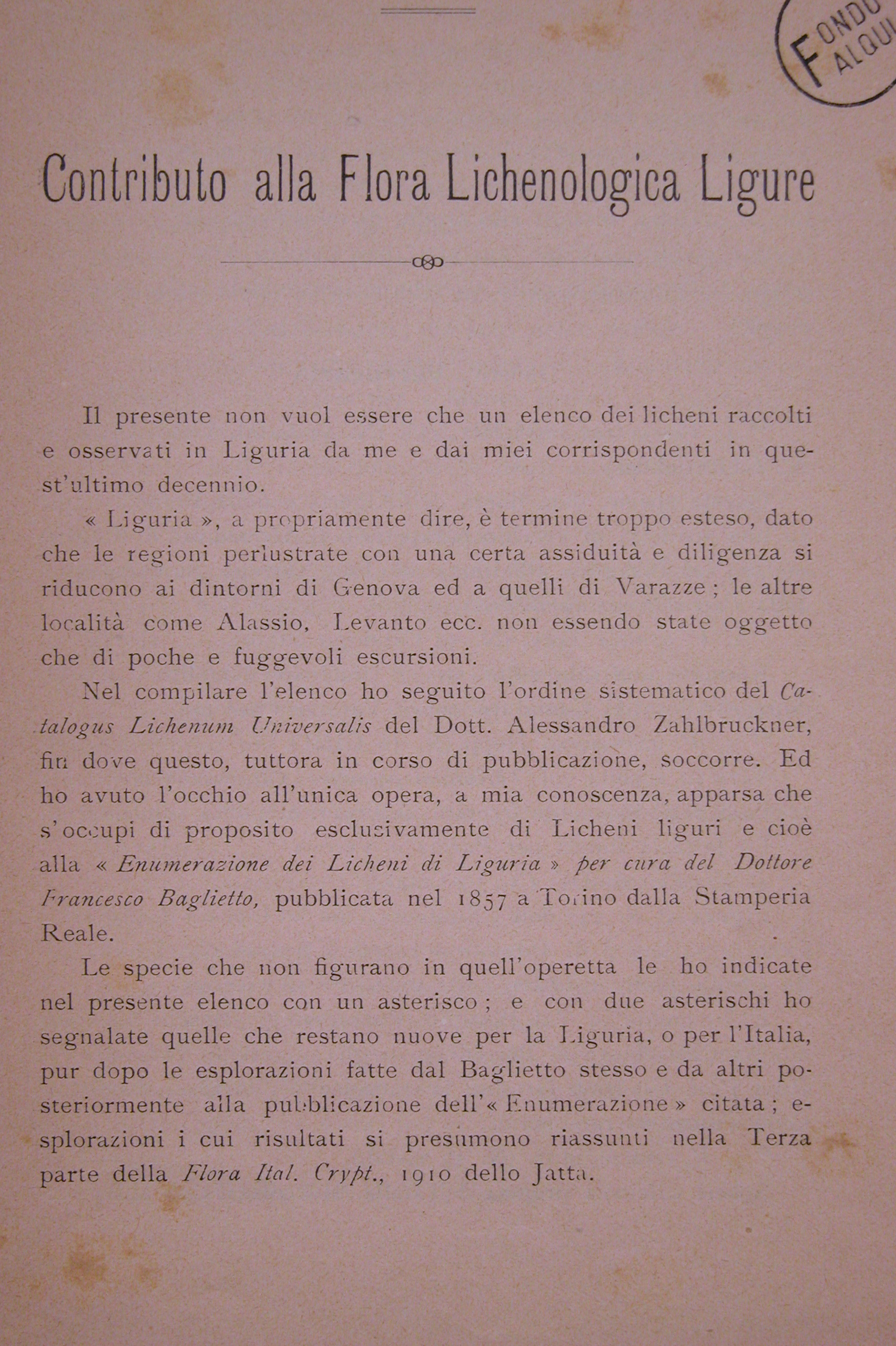 |
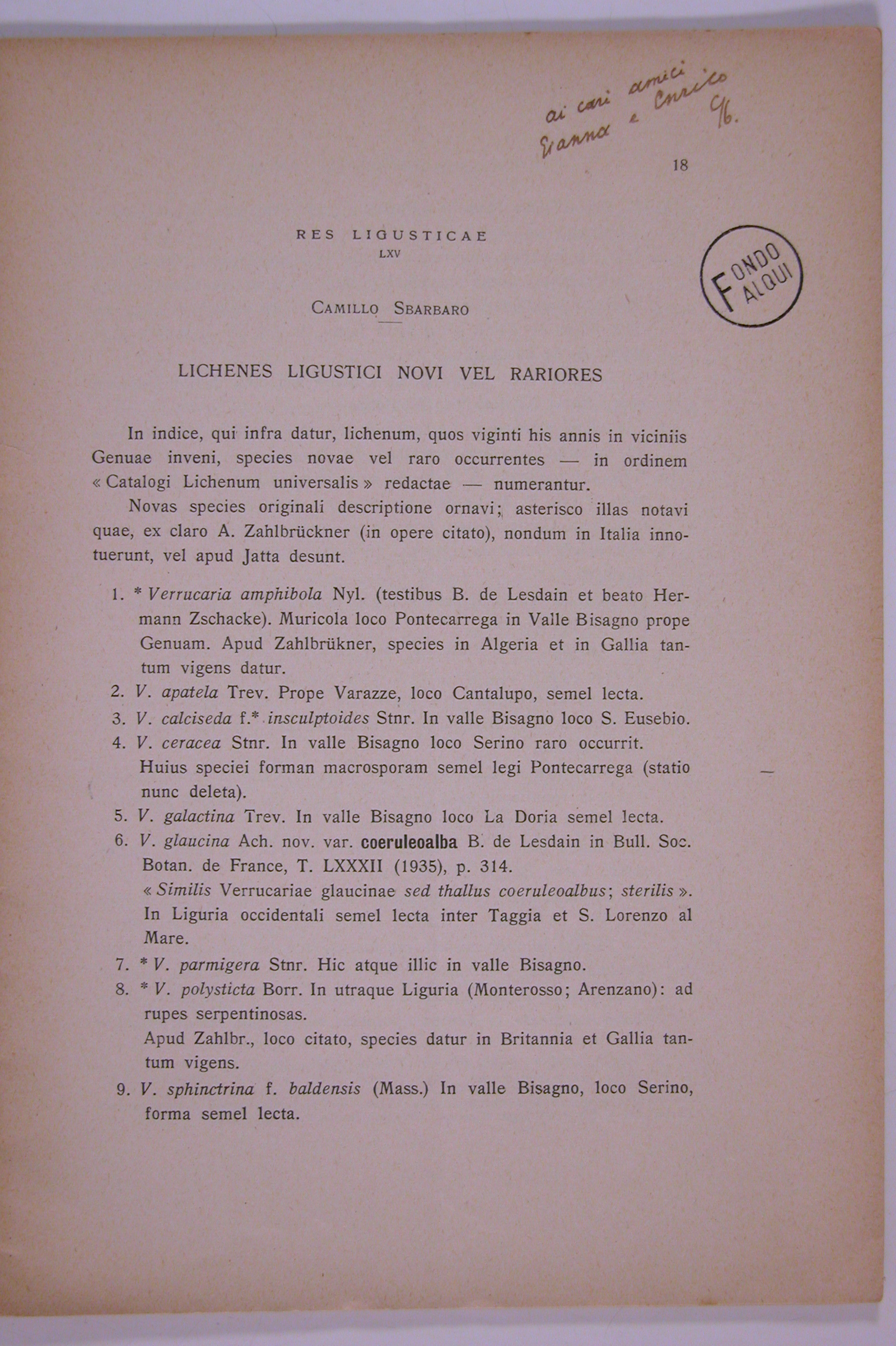 |
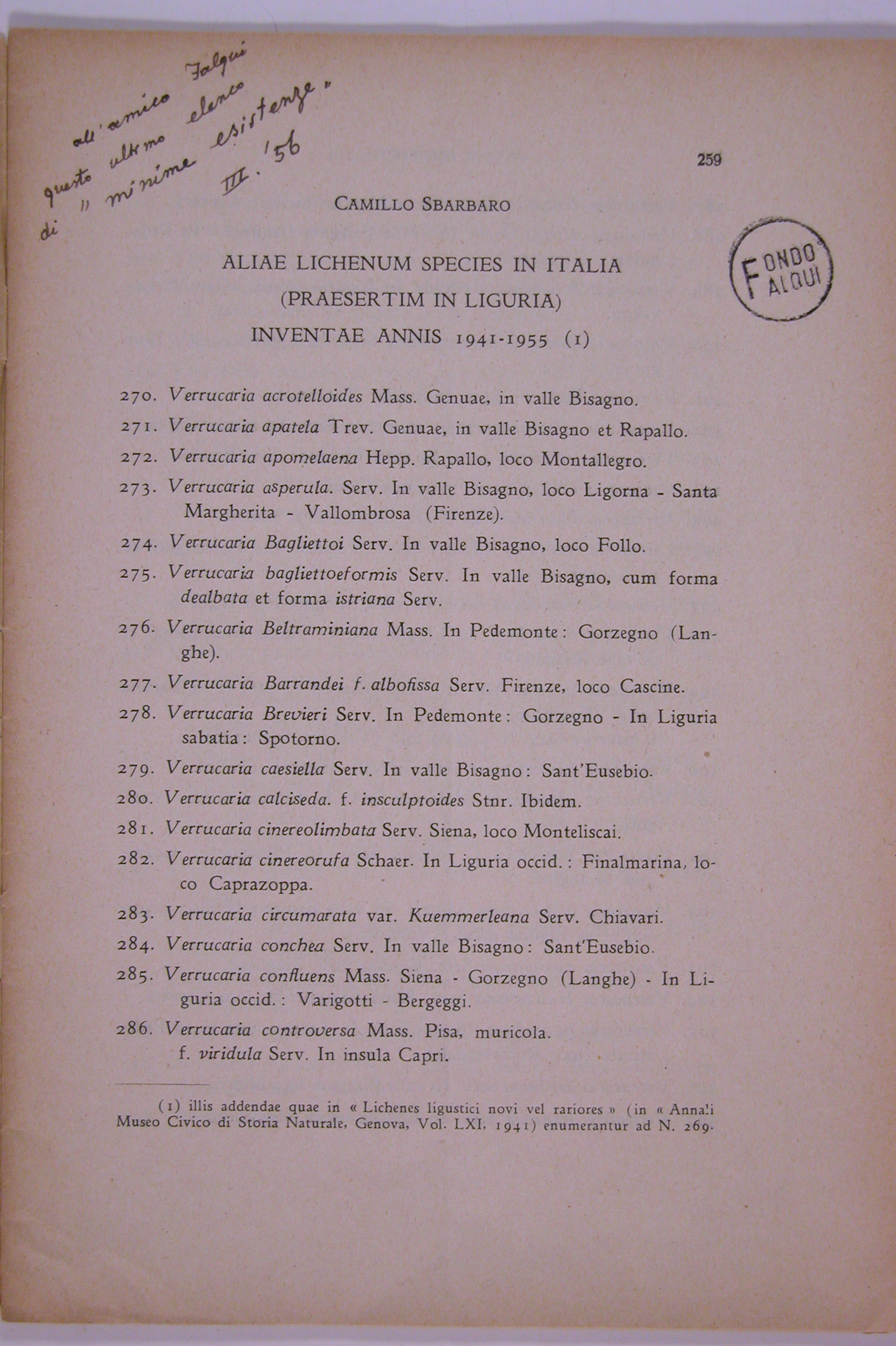 |






Bollettino '900 - Electronic Journal of '900 Italian Literature - © 2010
<http://www3.unibo.it/boll900/numeri/2010-i/Spalanca.html>
Giugno-dicembre 2010, n. 1-2