Francesca Cadel
Intervista a Vanna Vinci






Vorrei cominciare da una definizione possibile/auspicabile per il "fumetto" e faccio riferimento a queste parole di Igort, pronunciate nell'edizione 2013 di Pordenonelegge, che ho seguito via Twitter:
Igort: Il fumetto non costa niente, è la libertà gratis. Il privilegio della miseria #pnlegge2013Sei d'accordo con questa definizione, «letteratura disegnata»? È vero che «il fumetto non costa niente»?
#Igort: L'autore di graphic Novel è oggi simile ad un romanziere. Oggi parliamo di letteratura disegnata #pnlegge2013
Che l'autore di graphic novel sia simile a un romanziere o a un saggista o a un giornalista... sì, sono d'accordo. Il fumetto è, oggi come ieri, letteratura disegnata. Però si tratta di un linguaggio letterario e artistico autonomo.
Il costo del fumetto, in termini di (per così dire) spese vive è effettivamente molto basso. Per realizzare una storia a fumetti, creare personaggi, universi, viaggi nel tempo e nello spazio, serve solo un tavolo e qualche strumento tecnico, come carta, matita, penne, computer (ma se ne può anche fare a meno...). In effetti a un artista servono davvero pochissimi mezzi per creare un'opera a fumetti. Certo è molto meno impegnativo che fare un film, sia in termini di costi che in termini di risorse umane. Non si può nemmeno dire che ci voglia fatica fisica... È tutto un sistema oliato di cervello-mano...
Quali sono i tuoi punti di riferimento nella storia dell'illustrazione italiana e non?
In ordine molto sparso: le St. Trinian's e tutto il resto di Ronald Searle, Marcellina il mostro di Mary Lystad e Victoria Chess, La cattiva Lulù di Yves Saint Laurent, Saul Steinberg, Emanuele Luzzati, Grazia Nidasio, Hugo Pratt, Valentina di Guido Crepax, Magnus, Brunetta, Antonio Lopez, Mafalda di Quino, i Peanuts di Charles Schulz, Richard Scarry, Gianni de Luca, Dino Battaglia, Ben Shahn, Marcello Dudovich, Alice nel paese delle meraviglie di John Tenniel, Winnie-the-pooh di E. H. Shepard, Hayao Miyazaki, Waki Yamato, Ryoko Ikeda, Osamu Tezuka, Osamu Dezaki, Shingo Araki, Max Klinger, Bill Sinckieviz, Frank Miller, Sempé, René Goscinny, Odilon Redon, i film espressionisti tedeschi, i film americani degli anni trenta e quaranta... mi sarò dimenticata senz'altro qualcuno o qualcosa...
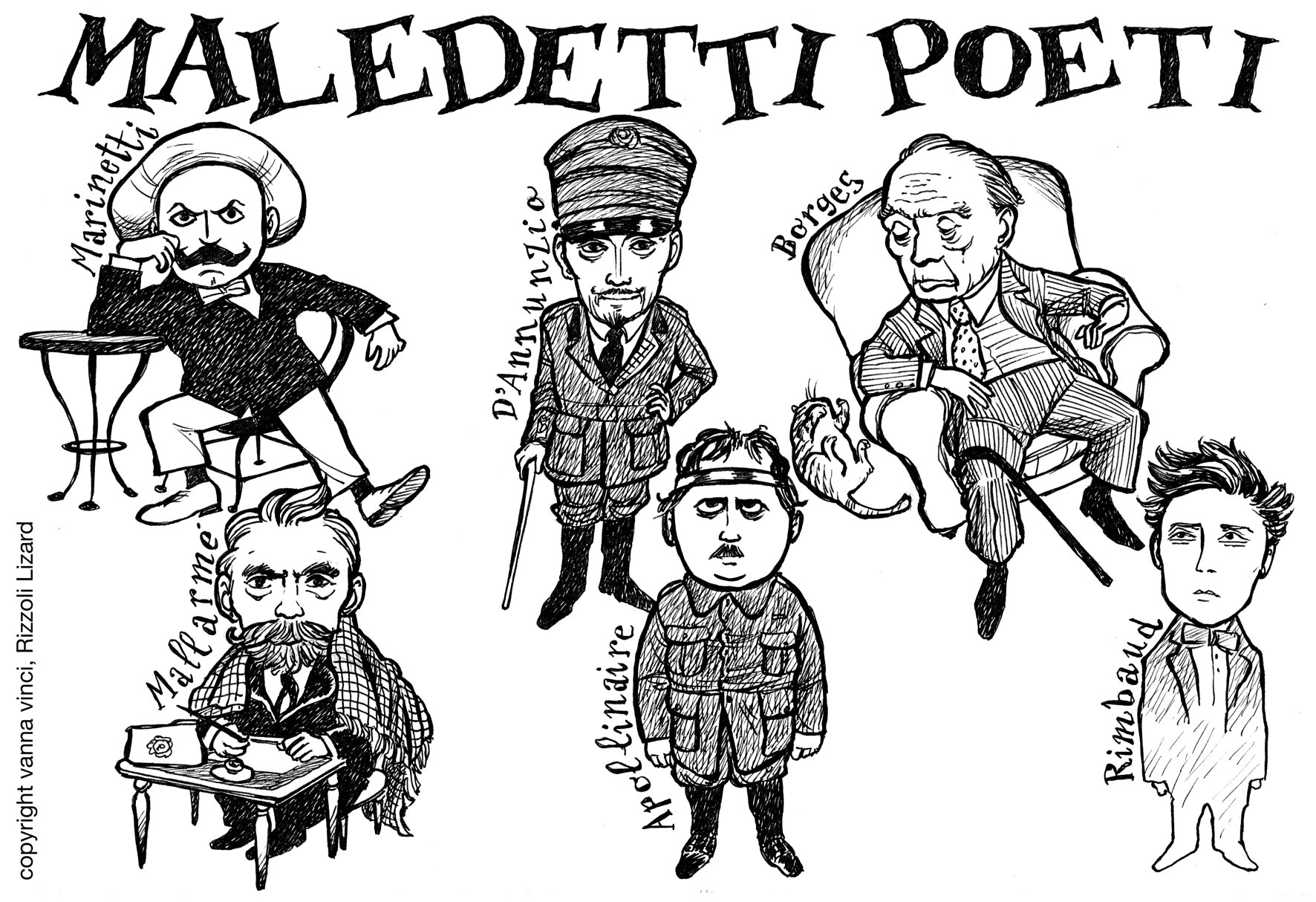 |
Come è nata e cresciuta in te la fiducia nel tuo talento?
In modo selvaggio. Come nella giungla. Mi sento molto Mowgli.
Anche per quanto riguarda la paura... mi sento sempre come se da qualche parte, nascosta, si acquatti una Shere-kaan o un Kaa... sono un animale del sottobosco, anche nell'habitat fumettistico.
Che ruolo hanno avuto Cagliari e Bologna nella tua formazione?
A Cagliari ho coltivato la mia parte antisociale e a Bologna quella sociale. Entambe sono state habitat fondamentali per il mio sviluppo.
L'Italia ha avuto una storia recente caratterizzata da un'anglo-americanizzazione nei costumi e nelle abitudini dei giovani: hai mai sentito la presenza di un fantasma coloniale anche in campo culturale?
Nessuno, nemmeno negli anfratti più nascosti della Nuova Guinea, credo possa fare a meno di sentire l'influenza colonizzatrice USA. Anche io, nella mia ignoranza e nel mio essere outsider, sono stata influenzata dai fumetti dei supereroi. A ben vedere però, se vogliamo storicizzare una colonizzazione più recente, dobbiamo parlare piuttosto di quella proveniente dal giappone, connessa con manga (fumetto giapponese) e cartoni animati. E io faccio parte anche di quella genia di autori e disegnatori folgorati da Goldrake e Lady Oscar. Sarà pure imbarazzante, ma è inutile negarlo. Penso che attualmente la colonizzazione USA e giappo sia in decadenza, e che forse ci troviamo immersi in una nuova colonizzazione francofona, ma bisogna chiedere ai critici, agli analisti... In ogni modo non ho nulla contro le colonizzazioni culturali, basta che siano mediate dall'intelligenza. Ma soprattutto credo che il colonizzato debba sempre mantenersi lucido e consapevole e non cercare di cancellare tutta la cultura di provenienza per cercare di trasformarsi in qualcosa di alieno. Insomma, credo che tutto possa essere assimilato, ma vada filtrato e digerito.
Non sono convinta che si possa essere iconoclasti a favore di altri culti diversi dal proprio, al limite bisogna usare influenze estranee per mettere in crisil'ordine costituito. Ma non per allinearsi a un altro ordine.
Quali sono le situazioni e i modelli che hanno ispirato La bambina filosofica?
Le bambine assassine di St Trinian's di Ronald Searle, Mafalda di Quino e Lucy di Schulz. Ma anche La cattiva Lulù di Saint Laurent e Marcellina il mostro di Lystad e Chess. Senz'altro anche tutti i pensatori e gli scrittori occidentali caustici e pessimisti (si può dire nichilisti... anche se forse non è del tutto corretto): per citarne qualcuno, non a caso, Kraus, Cioran, Lichtenberg. O artisti dissacranti come Paolo Poli.
Poi, molto del mood è quello familiare. La bambina filosofica è una sorta di autobiografia demenziale, ma tutto sommato abbastanza realistica.
 |
Puoi parlare del fumetto in italiano oggi? Quali sono le sue caratteristiche più autentiche, quelle che lo differenziano dal fumetto in lingua francese e inglese per esempio, ma anche dal manga giapponese?
Non so se so rispondere a questa domanda. Non sono un'analista del momento storico, sono immersa nel mondo del fumetto e nello stesso tempo sono talmente autoreferenziale da escludermene. Certo l'Italia, nella sua crisi perenne, ha prodotto da sempre autori molto personali, a volte seminali, che hanno agito con una libertà maggiore rispetto ai mostri sacri americani, francesi e giapponesi.
In Italia ci si prendono maggiori libertà, forse anche perché si è sempre un po' con le pezze al culo, quindi, diciamo, non ci sono milioni di euro da perdere.
Da questo punto di vista effettivamente può essere corretto l'Igort-pensiero che parla di «privilegio della miseria».
Qual è il ruolo della sceneggiatura nel fumetto e quali sono gli sceneggiatori con cui hai collaborato?
Ho lavorato praticamente solo con Giovanni Mattioli, se si escludono tre albetti brevi per Legs Weaver della Bonelli, che mi sembrano talmente marginali da poter essere tralasciati.
Lavorare in coppia creativa con uno sceneggiatore significa lavorare in due come farebbe un artista solo. Quindi non significa che lo sceneggiatore scrive quello che gli pare e poi il disegnatore come una macchinetta disegna, oppure che lo sceneggiatore scrive o addirittura aggiunge i testi nei balloon seguendo come un tappabuchi il lavoro del disegnatore.
Credo che la sceneggiatura, nel fumetto, sia una parte creativa e artistica fondamentale come il disegno. Senza la sceneggiatura il fumetto sarebbe solo una sequenza di disegni, magari ben fatti, ma non sarebbe fumetto.
 |
Come descriveresti la realtà dell'editoria italiana che pubblica fumetti d'autore oggi?
La vedo in una fase contratta, molto contratta, ma con delle possibilità evolutive inespresse e soprattutto spero imprevedibili.
Di sicuro l'aumento degli spazi nelle librerie di varia ha aperto dei canali che prima non esistevano o erano difficimente percorribili.
Credi in una funzione pedagogica del fumetto?
Come forma di linguaggio artistico no, perché se il fumetto è una forma d'arte, non credo che l'arte abbia nessuna funzione, se non quella di esprimere sé stessa.
Certo il fumetto può essere usato più facilmente di altri linguaggi artistici per materiali pedagocici, per esempio manuali d'istruzioni (vedi quelli di Will Eisner).
L'ultima domanda è relativa al successo: che cos'è per te e come ti identifichi rispetto al successo dei tuoi libri? È un mondo di donne e uomini? O di (prime) donne?
Non ho mai avuto successo coi miei libri, e non mi ci identifico.
Non saprei nemmeno dare una definizione ideale.
Per ora è un mondo di uomini e di primedonne... le donne sono pochissime e faticano.
Io rimango comunque nella mia marginalità.






Bollettino '900 - Electronic Journal of '900 Italian Literature - © 2014
<http://www3.unibo.it/boll900/numeri/2014-i/Cadel1.html>
Giugno-dicembre 2014, n. 1-2