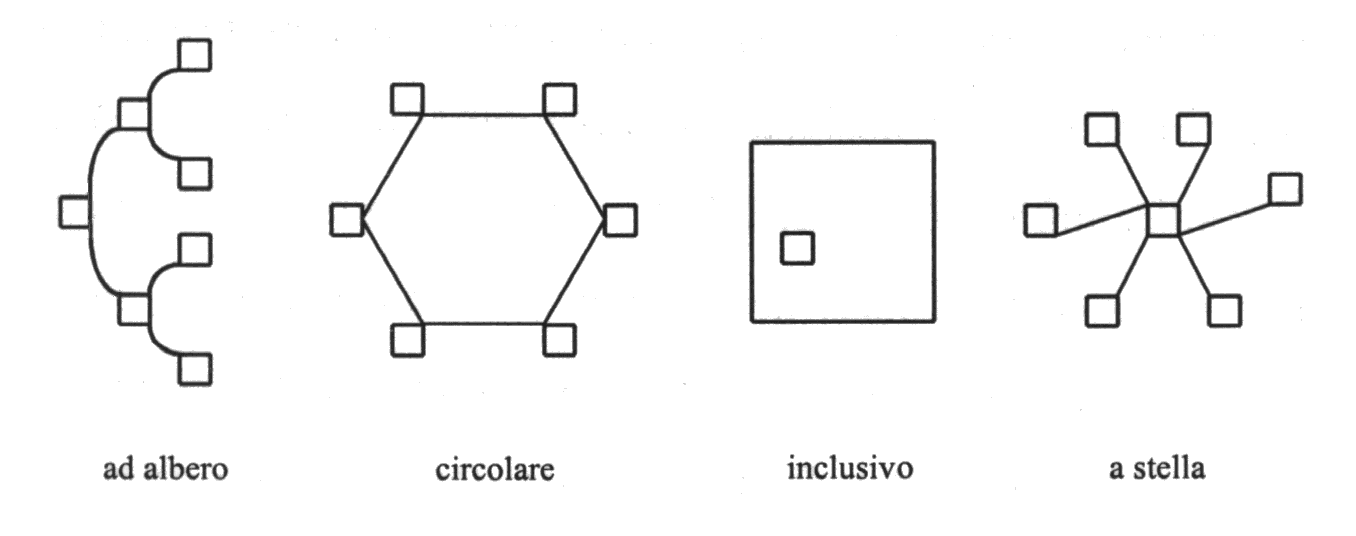Federico Pellizzi
Intertestualità e ipertestualità.
Generi marginali e discorso critico


1. Argomento
In questo intervento vorrei usare la nozione di ipertesto per riflettere sul nostro tema dei generi marginali. Non seguirò la via usuale, di pensare che certe opere letterarie siano in realtà ipertesti, o che la struttura ipertestuale le decostruisca, perché credo che idee simili nascano soprattutto da un fraintendimento di che cosa sia un ipertesto. Mi propongo invece di riflettere su alcune modalità oblique della scrittura che a mio parere contraddistinguono i generi marginali, e che la teoria ipertestuale può forse contribuire a comprendere.
Alcuni elementi del titolo (intertestualità e discorso critico) rimarranno un po' sullo sfondo, a indicare più che altro i confini, gli orizzonti che il tema a mio parere implica. Tuttavia verranno toccate questioni che riguardano lo statuto della scrittura letteraria, le nozioni di genere e di modo, e le possibilità attuali della critica letteraria. In particolare, cercherò di riflettere sui rapporti tra generi marginali (i diari, le epistole, gli appunti, i progetti, i resoconti, le autobiografie,1 le biografie, le cronache, ecc.). Si tratta di scritture assai eterogenee, le quali, sebbene occupino in alcuni casi un peso notevole nella letteratura moderna, sono spesso sottovalutate o relegate nel territorio della ricerca erudita: ma forse proprio ciò che esse hanno in comune - in una sorta di collaborazione reciproca - contribuisce a renderle, anche se in modo sotterraneo, importanti e caratterizzanti.
2. Generi marginali
Credo che qualche parola vada detta innanzitutto sulla definizione di "generi marginali", anche perché questo incontro inaugura il seminario, ed è bene avviare la discussione anche sull'oggetto teorico che sta alla base di queste sedute. Non pretendo di indicare linee guida, ma tento semplicemente di formulare alcune ipotesi di lavoro.
Viene naturale associare il termine "marginalità" a un gioco linguistico di matrice sociologica, in cui si fronteggiano centri e periferie, in una dialettica di oppressione e riscatto, e dove a volte l'operazione critica consiste nello spostare il valore dal centro alle periferie. Credo che si debba evitare in primo luogo di cascare in questo gioco. La marginalità, come vorrei che fosse intesa, riguarda due aspetti, uno interno, la forma di un particolare tipo di scrittura, e uno esterno, storico o epocale, lo statuto odierno della letteratura.
Indubbiamente la letteratura, nel panorama culturale dei nostri anni, occupa un posto "marginale". Credo tuttavia che sia più utile intendere anche questa marginalità nel senso che qui si suggerisce, ossia una particolare modalità di funzionamento, piuttosto che nel senso tradizionale, che spinge a vittimismi o a inumazioni premature della letteratura. Non credo per altro che la letteratura (e la critica) siano, tutto sommato, in crisi, e neppure, quindi, che marginalità vada intesa in questo senso. È in crisi, piuttosto, una particolare idea di "letteratura" e il sistema istituzionale e disciplinare che vi corrisponde. Ma ciò sembra suggerire che quel patrimonio di testi e di saperi che indichiamo in genere con la parola letteratura sta cambiando la propria funzione all'interno di un quadro più ampio di trasformazioni antropologiche. Muta, per dirla con Bachtin e Lotman, il modo in cui un testo letterario entra in rapporto con l'insieme della cultura (e quindi, gioco-forza, muta anche l'idea di testo letterario). Su questo piano l'ipotesi di una marginalità potrebbe riguardare, sì, una posizione non di primo piano del letterario, ma anche una maggiore integrazione, o scambio, con altre forme espressive e altri linguaggi. Non tanto in termini di ibridazione, quanto nel senso di ciò che si potrebbe chiamare una "intertestualità produttiva", ossia produzione di testi interrelati che costituiscono variazioni, sviluppi e integrazioni, anche attraverso altri media, di un testo o di un gruppo di testi di partenza. Lascio questa ipotesi di una letteratura "provvisoria" o "interstiziale", che del resto avanzavo anche nella presentazione di questo seminario,2 a un'eventuale verifica nelle prossime relazioni.
Sul piano interno, invece, la marginalità riguarda lo statuto di certi tipi di scrittura, che non appartengono ufficialmente a una zona riconosciuta e stabile della ricezione letteraria, ma stanno ai confini con l'extra-letterario, o palesemente, o in modo nascosto. Epistole, diari, appunti, progetti, script, autobiografie, relazioni, cronache, pur essendo diversissimi per funzione, forma e destinazione, condividono questa posizione di confine, e anche un'ambivalenza di fondo: aspirano al valore estetico anche se si muovono in una dimensione privata, preparatoria, o se dichiarano ufficialmente la propria extra-artisticità. Sono una forma di arte verbale privata che non disdegna l'esposizione, oppure una forma di commento pubblico che, pur negando la propria "letterarietà", assume le regole della comunicazione letteraria. Una delle proposte di questo seminario è di considerare queste forme come un insieme di generi che condividono alcuni caratteri comuni. Io credo che per poter compiere questa generalizzazione sia utile un cambio di scala, che permetta di considerare i generi marginali dal punto di vista delle strategie di enunciazione che li caratterizzano. È una prospettiva, a mio parere, che permette di trovare relazioni anche tra generi marginali nel loro insieme, "discorso critico" (ossia le varie forme di tipo saggistico in senso ampio), e ipertestualità.
3. Generi del discorso e generi terziari
Che cosa accomuna ipertestualità, discorso critico e generi marginali sul piano delle strategie di enunciazione, ossia sul piano della loro costituzione "discorsiva"? L'ipotesi, su un piano molto generale, è che condividano una modalità di enunciazione che ha bisogno di rifarsi sempre a un'alterità concreta, reale, esterna, che in qualche modo viene inclusa, prevista, o ricostruita nel discorso.
Prima di affrontare la questione in dettaglio, tuttavia, credo che sia opportuno anticipare qualcosa sul mio modo di vedere l'ipertestualità, per mostrare sotto quali aspetti essa abbia a che fare con le modalità di enunciazione. La mia impostazione rispetto alle tecnologie digitali aspira ad essere sostanzialmente fenomenologica. Cerco qui di considerare l'ipertestualità innanzitutto sul piano della sua costituzione materiale, rifuggendo da ogni feticismo dell'oggetto. Intendo dire che mi propongo di osservare come essa funziona concretamente e le forme effettive che assume, evitando sia di metaforizzare a priori certe sue caratteristiche, sia di fare dell'oggetto nella sua presunta unitarietà un emblema epocale. Perciò distinguerò i termini ipertesto e ipertestualità.3 L'ipertestualità è la modalità di funzionamento della scrittura digitale in generale. Un ipertesto è una particolare realizzazione testuale di questa modalità.
L'ipertestualità non è una forma specifica e circoscritta tra le forme possibili di scrittura digitale, bensì un carattere fondamentale del digitale in quanto tale. Il digitale è ipertestuale per propria costituzione, e ciò si osserva non appena è coinvolto un "lettore"; vale a dire, ogniqualvolta il digitale assuma una qualsiasi forma testuale. Uso "ipertestualità" (come del resto "testualità") in un'accezione molto ampia senza rinunciare, credo, all'esattezza dei concetti. "Iper-" indica un potenziamento, "testualità" l'esistenza di insiemi sufficientemente coerenti, coesi, delimitati e riconoscibili di segni. Il digitale rende questi insiemi, queste configurazioni testuali, dinamici, interattivi, stratificati, connettibili ad altri insiemi e soprattutto ad azioni e processi. Si tratta quindi di una nuova forma di scrittura, sotto il profilo materiale, tecnologico e sociale: una forma che rivoluziona il rapporto tra scrittura, testo e discorso. In ciò risiede la radicalità del digitale, la sua grande rilevanza antropologica.
Non è quindi difficile notare come il digitale sia anche una nuova forma di discorso, che permette di connettere oggetti, simboli e azioni in modo nuovo. Penso pertanto che l'ipertestualità costituisca non solo un nuovo "modello testuale" in via di formazione, ma anche un "modello discorsivo", ossia una strategia di enunciazione caratterizzata da particolari modalità sintattiche, retoriche, pragmatiche.
Se tuttavia l'ipertestualità inaugura anche un nuovo modo di connettere, di fare discorso, va notato che per una certa sua capacità inclusiva e commentativa essa è in grado di porsi su un piano più ampio rispetto ad altre modalità discorsive: è una modalità che definirei "architettonica", in grado di coordinare pressoché tutti i tipi di discorso, disponendoli (ordinandoli) nello spazio-tempo di una nuova testualità operativa, e rendendo possibile, entro una certa misura, l'espressione correlata di ciascuno di essi.
Quindi componente essenziale dell'ipertestualità è l'aspetto meta-discorsivo: l'essere un discorso che ha per oggetto altri discorsi. È subito chiaro, però, che questo "avere per oggetto" non va inteso nel senso astratto della metalinguistica, bensì nel senso letterale, concreto, dell'avere a che fare con altri discorsi, e del dovere, in qualche modo, gestirli.
Riprendendo la domanda generale che mi sono posto, se cioè ci sia qualche elemento che accomuna ipertestualità, discorso critico e generi marginali, anticipo, sulla base di queste osservazioni, una specie di conclusione provvisoria che poi va discussa. Tra queste tre forme, anche se sembrano di natura, ampiezza e funzione diversissime, si riconosce un primo elemento di affinità nel fatto che esse istituiscono al proprio interno un rapporto di alterità (con altri testi, eventi, oggetti) e assumono una forma tendenzialmente meta-discorsiva.
È dunque necessario, per trovare un luogo di comparazione tra ipertestualità, discorso critico e generi marginali, individuare una zona teorica che dia conto della forma generale del discorso, delle tipologie discorsive che caratterizzano gruppi di generi. Chiamerò questa zona delle grandi tipologie discorsive la zona dei "generi terziari". Ricondurre i generi marginali a un'unica tipologia discorsiva potrebbe sembrare una forzatura, soprattutto perché, come si è già notato, essi si mostrano, a un primo esame, assai eterogenei. I generi marginali sono di fatto "generi letterari" a tutti gli effetti, distinti tra loro e quindi dotati ciascuno di uno statuto "secondario", modellato su collaudate regole di produzione e di ricezione. Non solo, ma alcuni di essi (per esempio le lettere, le autobiografie e i diari) sono tra i generi del Novecento, e in generale della modernità letteraria, che godono di una maggiore riconoscibilità e stabilità. Sono, cioè, nonostante la loro apparente posizione defilata, generi "forti", presenti e influenti nell'immaginario e nella produzione letteraria. Ma qui si è parlato piuttosto di "generi terziari", proprio per cercare di introdurre un parametro al tempo stesso più analitico e più vasto. Mi richiamo, a questo proposito, alle riflessioni di Bachtin sui generi del discorso, cercando di completarle in funzione dei problemi che qui ci interessano.4
Lo studio di Bachtin sui generi del discorso è anche una proposta di storiografia letteraria. Bachtin si riallaccia alle riflessioni linguistiche della fine degli anni Venti, e quindi gli preme «gettare luce sulla natura dell'enunciazione»;5 ma al tempo stesso ritiene che mostrare il funzionamento storico e sociale del linguaggio, che si incarna nelle enunciazioni concrete e nei generi del discorso, possa far comprendere meglio anche la natura, la storicità e l'individualità degli stili e delle opere letterarie. A questo fine Bachtin invita a tenere sempre correlati «generi del discorso primari (semplici) e secondari (complessi)»,6 ossia generi del discorso propriamente detti e generi letterari in senso lato, perché questo rapporto può aiutare a capire qualcosa «sul problema complesso dell'interrelazione tra la lingua e l'ideologia, la concezione del mondo».7 Di là dagli obiettivi polemici,8 Bachtin cerca di superare tutte le impostazioni che separano la genesi del discorso dalla sua cristallizzazione, recuperando una storicità che sta immersa nella vita quotidiana: «La lingua, infatti, penetra nella vita attraverso le enunciazioni concrete (che si attuano) ed è attraverso le concrete enunciazioni che anche la vita penetra nella lingua».9
Per quanto riguarda la messa a fuoco della natura dell'enunciazione Bachtin anticipa in parte, già nel 1929, certe impostazioni anglosassoni di filosofia del linguaggio,10 ma avendo presente un quadro antropologico, a mio parere, molto più vasto. Per quanto riguarda la letteratura, forse, quanto ci rimane del progetto bachtiniano non colma tutte le lacune. È come se mancasse l'anello di congiunzione tra generi primari e generi secondari. La menzione di «unità tematiche» e «compositive» non è sufficiente,11 così come non lo è nemmeno lo sbocco della teoria bachtiniana dei generi del discorso, ossia la distinzione tra monologico e dialogico.
La poetica e la retorica antiche ci possono forse venire in aiuto. Tra generi primari (come la domanda, la preghiera, l'ingiunzione, l'ordine, l'esclamazione, la promessa) e generi secondari (come «il romanzo in più volumi»), si pone un ordine più generale, che quindi abbiamo chiamato dei generi terziari, ma al tempo stesso intermedio, perché si pone tra l'oralità e la scrittura, tra la situazione e il testo, che definisce la modalità di enunciazione.
Limitandosi alle indicazioni che ci possono venire dalla poetica (e lasciando per il momento le distinzioni della retorica), i due modelli classici, platonico-aristotelici, di generi terziari sono il tipo drammatico e il tipo narrativo. Aristotele nella Poetica parla in realtà di generi letterari (secondari), ma individua come uno dei criteri per classificarli un principio più generale, di carattere formale: la maniera (o modo) di imitare [1447 a, 15]. Aristotele allude alla modalità di enunciazione. Egli dice sostanzialmente che la «maniera» di imitare è stabilita nel rapporto tra colui che enuncia (che possiamo chiamare enunciatore), referente e azione [1448 a, 20]. Una modalità mediata, riflessiva, in cui l'enunciatore ricorre a «personalità diverse» e rievoca l'azione, è quella narrativa; una modalità immediata, immersiva, in cui gli attori rappresentano direttamente l'azione e simulano di essere e di fare ciò di cui si parla, è la drammatica [1448 a, 23].
Gérard Genette si è soffermato incisivamente su queste pagine aristoteliche. Credo tuttavia che si debba forzare la distinzione di Genette a questo riguardo. Nell'Introduzione all'architesto Genette afferma:
«La differenza di statuto tra generi e modi risiede essenzialmente in questo: i generi sono categorie propriamente letterarie, i modi sono categorie che dipendono dalla linguistica, o più esattamente da ciò che oggi si chiama pragmatica».12
In questo modo è come se la differenza tra modi e generi risiedesse nel punto di vista da cui si osserva, e la preoccupazione teorica consistesse nel non confondere tra loro due approcci metodologici e disciplinari. Sulla scorta di Bachtin, tuttavia, è preferibile ritenere che generi del discorso e modalità enunciative possano considerarsi categorie che rientrano a pieno titolo anche nella sfera di interesse della letteratura, tanto quanto i generi letterari, e che le modalità enunciative in particolare costituiscano una classe autonoma di generi del discorso.
In base alla modalità di enunciazione, se si sfuma la distinzione tra fiction e non fiction, e tra oralità e scrittura, è possibile individuare altri generi terziari che si sono imposti nel corso della storia, alcuni più ortodossi, come il tipo lirico, altri meno ortodossi, come il tipo "enciclopedico". Che quest'ultimo possa essere considerato (anche) un genere terziario del discorso può sembrare discutibile, ma non è comunque peregrino, perché si tratta di un modo di presentare il discorso che implica non solo una particolare dispositio, ma anche un rapporto specifico tra enunciazione, referenza e ricezione, ossia un particolare modo di leggere.
Il genere enciclopedico,13 che influenza notevolmente anche molti generi letterari, è un tipo di enunciazione oggi tra i più diffusi. Consiste nel presentare il discorso per nuclei indipendenti, ordinati secondo un criterio esogeno (come ad esempio l'ordine alfabetico, ma i criteri possono essere molti altri). Il "genere enciclopedico" è un genere terziario accostabile in qualche modo all'ipertestualità? Indubbiamente ci sono dei legami forti, soprattutto se si segue l'interpretazione più diffusa, che vuole l'ipertestualità come espressione della vittoria del discreto sull'analogico. Il discorso enciclopedico potrebbe essere assimilato, ad esempio, alla «logica del database» di cui parla Lev Manovich.14 Tuttavia credo che il genere enciclopedico, seppure importante, non sia il genere terziario dominante nell'ambito dell'ipertestualità, e che vadano individuati altri generi terziari che svolgono un ruolo più significativo.
In base al "modo dell'enunciazione", soprattutto se si esce dalla gabbia della mimesis, si possono individuare altri generi terziari, che offrono una particolare configurazione del rapporto tra l'enunciatore, quelli che chiamerei il tema e il rema dell'enunciazione,15 e l'enunciatario. Si mette in luce, cioè, una categoria di generi, definibili in base al tipo di rapporto con il referente, con l'interlocutore o con il pubblico. Altri esempi di generi terziari potrebbero essere il genere argomentativo, il genere critico o il genere parodico.16 Non intendo certamente affrontare qui il problema in modo sistematico, ma solo individuare un'area teorica, da cui trarre qualche indicazione sui legami tra ipertestualità e i generi marginali. Credo però che l'individuazione di questa area teorica di generi terziari possa dar conto, seguendo la prospettiva bachtiniana, di certe relazioni, anche nel "tempo grande", tra testi e storia, tra linguaggio e scrittura. Se ne può avere anche qualche riscontro empirico, osservando quali modalità di enunciazione agiscano in produzioni reali, passando dal piano dei generi (siano essi primari, secondari o terziari), a quello di particolari tipologie che definirei "pubblicistiche". Che dire ad esempio dei giornali quotidiani? È evidente una loro dipendenza dal genere terziario enciclopedico, anche se ibridato con altri generi primari e secondari (di certo in ogni produzione reale non si danno generi "puri", e si tratta di individuare semmai quelli dominanti). Qui si aprirebbe un grande campo di studio, ma non voglio certo inoltrarmi in questa direzione. L'intento era mostrare, battendo le zone di confine del nostro tema, come la stessa nozione di intertestualità andrebbe completamente ridefinita e allargata anche in base a una teoria più completa dei generi del discorso.
Tornando al punto, questo piano terziario dei generi discorsivi è confrontabile in qualche modo con i «modi» di Frye, con i «tipi» di Todorov, con le tipologie testuali della linguistica testuale e con alcune tipologie discorsive della retorica. Penso in ogni caso che non si tratti tanto o solo di un differente modo di guardare la questione dei "generi", quanto di riconoscere l'esistenza storica di "categorie" oltre che di "enti" e testi. Perciò sostenevo che bisogna andare oltre la distinzione di Genette, e credo che la questione non sia tanto di passare dall'induttivo al deduttivo, come sostiene Todorov, quanto di individuare convenzioni discorsive più ampie e qualitativamente differenti rispetto alle enunciazioni che si producono nel linguaggio (primarie) e alle enunciazioni che si producono nella scrittura (secondarie). Credo tuttavia che questa "zona" dei generi terziari non sia assimilabile a quella delle «formazioni discorsive» di Foucault, né ai «giochi linguistici» di Wittgenstein, perché in questi casi il fondamento è sostanzialmente tematico e contestuale. Qui si tratta invece di un fatto in primo luogo formale, anche se con base storica, che riguarda la modalità del rapporto tra istanza dell'enunciazione, tema e rema testuale, e istanza della ricezione. Avrò modo di tornare su questi aspetti in seguito. Intanto va detto che anche la linguistica testuale, con intenti teorici e al tempo stesso didattici, ha individuato alcune tipologie testuali che, bene o male, definiscono una zona che non appartiene né al campo dei generi primari, né a quello dei generi secondari.17 Tuttavia la linguistica testuale adotta per lo più, come la retorica, un punto di vista funzionale, pragmatico e didascalico al tempo stesso, che consente perciò di mettere a fuoco aree di incidenza di gruppi di generi secondari, più che una nuova classe teorica di generi.18
Prendendo in considerazione la morfologia del discorso, ossia il modo dell'enunciazione, viene da pensare che, pur non trascurando la progettualità, gli usi e i contesti del discorso, si possano individuare invece delle tipologie che costituiscono dei modelli dinamici di raccordo tra generi primari e secondari.
Particolarmente utile, a questo proposito, appare la riflessione successiva di Genette sui tipi di «trascendenza testuale», definizione alla quale Genette attribuisce solo un significato tecnico, in quanto «trascendenza» è il contrario di «immanenza».19 Genette parla insomma della tendenza di un testo ad uscire da se stesso. In realtà mi sembra che la trascendenza testuale così intesa sia una caratteristica della testualità in quanto tale. Genette infatti afferma che la transtestualità è da intendersi non come classe di testi, ma come «un aspetto della testualità e a fortiori, come direbbe giustamente Riffaterre, della letterarietà».20
Mi pare che tale caratteristica sia associabile al concetto husserliano di intenzionalità. In questo senso credo che andrebbe integrata la nozione di intenzionalità proposta da de Beaugarde e Dressler nel loro libro sui criteri della testualità.21 La testualità è innanzitutto, bachtinianamente, un riconoscimento di alterità, una dichiarazione di insufficienza, una proiezione verso altro da sé: ci sono dunque diversi gradi di intenzionalità testuale, dal grado zero, che ha come fine il compimento del testo (per de Beaugarde e Dressler si tratta del fine operazionale della coesione e della coerenza, che ha come contropartita l'accettazione da parte del ricevente),22 fino a gradi più complessi, illocutivi, performativi, transdiscorsivi e transtestuali. In questa direzione andrebbe, a mio parere, ripensata una teoria dell'intertestualità. Ma ciò che importa ora è che questo aspetto della trascendenza testuale da un lato ci riconduce al rapporto d'alterità che, come si è visto, in modo differente istituiscono generi marginali, ipertestualità e discorso critico, dall'altra fa pensare che i diversi gradi di questa relazione con l'alterità abbiano intimamente a che fare con le modalità di enunciazione, e quindi con l'area teorica dei generi terziari che qui si è voluta individuare.
Si possono avvertire, nel discorso di Genette, una certa ambiguità e alcune sovrapposizioni tra le sue tipologie transtestuali e certi generi letterari. Nelle prime pagine di Palinsesti, definendo una di queste tipologie, l'architestualità, Genette nomina, distrattamente, proprio i tre livelli che qui si vogliono differenziare: generi del discorso, modi d'enunciazione, generi letterari.23 E a guardar bene alcune di queste tipologie transtestuali si possono mettere in relazione, più che con i generi letterari, proprio con alcuni generi terziari; e due, in particolare, interessano il nostro discorso: Genette dice ad esempio che la relazione meta-testuale «è, per eccellenza, la relazione critica».24 Quindi il commento è forse un aspetto, una declinazione di questa relazione critica, e perciò, prima di incarnare un genere secondario particolare, è riconducibile, in quanto forma di enunciazione, a un genere terziario. Lo stesso vale per l'ipertestualità genettiana, oggetto di Palinsesti: essa costituisce una famiglia di rapporti d'alterità e di forme di enunciazione, e non tanto una categoria che raccoglie tutti i tipi di generi "parodici" in senso lato.
Come è noto Bachtin, nel suo libro su Dostoevskij, fornisce una tabella dei tipi di parola dialogica, che potrebbe assomigliare a un tentativo di articolazione di generi del discorso. Credo tuttavia che non si possa generalizzare quello schema, nato in quel contesto, per altri fini: ciò vale a maggior ragione nel caso del pensiero bachtiniano, che è quanto di meno tassonomico si possa trovare (e in ciò è del tutto opposto al modo di procedere di Genette). Il pensiero di Bachtin è aderente, partecipe: non genera classificazioni, ma contesti dialogici in cui intervengono le sue idee fondamentali.
Quindi quello schema può essere preso come un singolo livello d'applicazione di idee che nondimeno vanno applicate anche ad altri livelli, se è necessario. Ed è quello che ho cercato di fare individuando l'area teorica dei generi terziari.
Si può dire dunque che generi marginali, ipertestualità e discorso critico sono influenzati fortemente, oltre che dal genere terziario enciclopedico, da altre due famiglie di generi terziari, di tipo meta-discorsivo e iper-discorsivo; e possiamo individuare, alla luce di ciò, anche altri aspetti, tipici di questi generi terziari, che li accomunano. In particolare vorrei soffermarmi su due di essi.
Il primo elemento è una sorta di "tabe" riflessiva. Abbiamo visto che i generi marginali possiedono la caratteristica di porsi in un rapporto di alterità rispetto a qualcosa che sta indubbiamente fuori di essi, e che diventa l'oggetto più o meno esplicito del loro discorrere: tale caratteristica è accompagnata spesso da un esercizio del pensiero o della memoria, della critica o dell'interpretazione.
Il secondo elemento è la predisposizione a un'autorialità collettiva, a una polifonia reale, permessa proprio dalla forma della loro modalità discorsiva, intimamente dialogica.
Per quanto riguarda il primo elemento, il carattere riflessivo, va notato che è un loro aspetto costitutivo sia nel senso galileiano (ottico, visivo, e poi mentale), sia nel senso etimologico, di piegare, di torcere, di far sì che qualcosa venga trasformato, qualcosa che sta fuori, qualche cosa a cui il testo si riferisce e che può venire in qualche modo ospitato. Su questo aspetto pragmatico ci sarà occasione di tornare. In generale, l'aspetto riflessivo esprime sia l'inclinazione meta-discorsiva, sia l'inclinazione iper-discorsiva, in senso lato, a cui si accennava a proposito dell'ipertestualità.
Ma c'è anche un altro risvolto, cioè il carattere referenziale di questi tipi di enunciazioni. Per i generi marginali, come per il discorso critico, si tratta ovviamente di una referenzialità diversa da quella di un trattato di medicina, e più simile a quella della storiografia, anche se con alcune differenze. Il referente dei generi marginali non è astratto, ma incarnato e individuale. È ciò a cui si risponde e che a sua volta risponde. È qualcosa di storico e concreto, qualcosa che vive intorno al costituirsi della scrittura. Per quanto riguarda l'aspetto referenziale in un ipertesto, invece, le cose si pongono in parte su un piano diverso, e su ciò cercherò di dire qualcosa più avanti.
Per quanto riguarda il secondo elemento, la predisposizione di un'autorialità collettiva, si può constatare che essa è spesso presente nei generi marginali ed è anche comune a certe forme di scrittura - sul piano che si è definito prima delle tipologie "pubblicistiche" - fiorite (nella modalità che interessa qui ora) proprio tra Otto e Novecento, come le riviste o le antologie: sarebbe forse utile una riconsiderazione globale di riviste, antologie, raccolte, ma anche di carteggi ed epistolari, dal punto di vista della loro dialogicità immanente. Le riviste sono un "genere" collettivo, e non un insieme di articoli, perché costituiscono un complesso di voci che si concertano in uno spazio segmentato, allo stesso modo di tante altre scritture legate al giornalismo. In questo caso c'è qualche affinità con le strategie del genere terziario enciclopedico, che è infatti particolarmente incline alla pluriautorialità. Un'antologia è a sua volta, per altri versi, un "genere" collettivo, anche se di tipo differente, perché la sua funzione è più direttamente esemplificativa e meta-testuale. Avremo modo, visto che il seminario procede su questo terreno, di incontrare alcune di queste forme diverse, di verificare se queste sono ipotesi produttive. Anche la testualità digitale è, direi nelle sue fondamenta, un tipo di scrittura collettivo, cioè richiede la partecipazione di molti autori nel suo costituirsi, nell'essere mantenuta e nell'essere fruita.
Per quanto riguarda i generi marginali forse questa dimensione pluriautoriale è apparentemente estranea ad alcune scritture private, come il diario. Spesso tuttavia il tessuto ad alta densità intertestuale di tali scritture reintroduce la dimensione pluriautoriale in forma intensiva, in un fitto dialogo con testi altrui o in termini di bivocità. Le epistole sono a loro volta enunciazioni che partecipano a un più vasto scambio pluriatoriale, reso, sul piano "pubblicistico", da carteggi ed epistolari.
Credo che a questo punto risulti chiaro come il termine di marginalità non abbia nulla a che vedere, come viene detto anche nel documento di presentazione di questo seminario,25 con una marginalità rispetto a un centro, rispetto a generi "alti", più importanti. È piuttosto una marginalità senza centro di riferimento, un essere sempre a lato, un essere sempre contiguo. Essendo questo un carattere tipico di molte scritture letterarie che non occupano il primo piano, è facile far coincidere "generi marginali" e "generi minori". In realtà non c'è coincidenza, anche se spesso accade che di fatto le scritture di quel tipo siano considerate meno importanti: la marginalità riguarda un fattore costitutivo piuttosto che occasionale, cioè l'intima referenzialità e dialogicità intorno alla quale si costruisce la scrittura.
4. Ipertestualità
Di marginalità parla anche un classico della teoria sull'ipertesto, Hypertext, di George Landow.26 È in realtà un libro che si presta a molte critiche - alle quali accennerò in seguito. Il titolo inglese prosegue con il sottotitolo Convergence between contemporary literary theory and technology, che mostra la tesi generale dell'opera, ossia l'ipotesi di una convergenza, o addirittura di una coincidenza tra teoria letteraria (post-strutturalista) e tecnologie ipertestuali.
Nel capitolo intitolato «Riconfigurare il testo» Landow cerca di presentare la teoria di un «testo disperso», dai confini offuscati, che permetta di mostrare questa tendenza. Mettendo a confronto testo a stampa e ipertesto, Landow esamina il ruolo che, nell'uno e nell'altro, ogni porzione testuale intrattiene con tutte le altre, e si sofferma in particolare sul ruolo della "nota". Prendendo il termine da Barthes, egli chiama le porzioni di un ipertesto «lessìe», e mostra come il testo digitale superi le esigenze di sequenzialità e gerarchia del testo a stampa, creando una struttura dinamica multilineare immanente.27 Già un certo modo di intendere il testo a stampa aveva aperto la strada a questa impostazione. E oltre ai nomi di Foucault, Derrida e altri, Landow chiama a testimoniare Bachtin.
Landow ricorda ad esempio che per Bachtin le note sono «più simili a glosse che a note autoritarie»,28 cioè sono divagazioni o espansioni indipendenti più che censure o investiture di autori citati, e non sono porzioni di testo con una determinata posizione gerarchica rispetto al resto del testo. Dopo aver citato Bachtin, anzi, più che Bachtin, in verità, un commento della sua traduttrice americana Caryl Emerson, Landow ribadisce questo aspetto della mancanza di gerarchia e afferma:
«[...] il testo collegato, l'annotazione, esiste come un altro testo, e conduce all'idea (e all'esperienza) del testo come Altro. Nell'ipertesto questa annotazione, commento o testo integrativo può essere qualunque testo collegato, e dunque la posizione di una lessìa dell'ipertesto ricorda quella del saggio vittoriano. Come il saggio, come ad esempio Carlyle, Thoreau o Ruskin, la lessìa sta al di fuori, decentrata, e lancia un sfida. In altri termini, l'ipertesto, come il saggio, prospera sulla marginalità».29
Landow traccia un parallelo tra ipertestualità e saggio vittoriano sulla scorta del concetto di marginalità.
«Da quella marginalità essenziale, da cui lancia le proprie affermazioni, da cui con un uso abile e aggressivo dei pronomi, oppone i suoi interessi e i suoi modi di vedere a quelli del lettore, egli definisce la sua posizione discorsiva o la sua prospettiva».30
«Anche l'ipertesto rivendica che il marginale ha tanto da offrire quanto il centrale».31
Vedete che qui Landow non evita il pericolo della contrapposizione retorica di marginale e centrale, ma è importante che la marginalità sia legata all'assunzione di un punto di vista rispetto ad un altro testo. Landow mostra la somiglianza tra saggio e ipertesto in base a questo rapporto di alterità, e ciò ci riconduce a quanto dicevamo prima. È un carattere estensibile agli altri generi marginali. I generi marginali sono spesso, di fatto, essi stessi commenti o note a margine, o coordinazioni di altri testi, o risposte ad altri testi (come le epistole); oppure sono esplicitamente etero-referenziali, scritture ibride che si pongono a lato di qualche evento o successione di eventi, o che prendono in esame (come nei diari, nei resoconti, negli appunti e nelle lettere) fatti esterni e persone. Oppure, si rivolgono direttamente a un destinatario, sono forme di scrittura esplicitamente allocutive. Tutti aspetti che la testualità digitale può fare propri, e che anzi ingloba come fattori costitutivi del proprio funzionamento. Nel caso della testualità digitale si tratta spesso di scritture che si riferiscono ad altre scritture, spesso appartenenti al patrimonio preesistente; o di presentazioni, interpretazioni di scritture preesistenti. E questa è anche una caratteristica essenziale, o almeno la più evidente, dell'ipertestualità.
Io credo tuttavia che nell'ipertestualità questo "riferirsi a" corrisponda anche a una ragione più profonda, costitutiva, legata all'essenza simulatoria del digitale. Come accennavo poco fa, l'etero-referenzialità del digitale è specifica e ha effetti culturali profondi. Il digitale ha bisogno di un'assoluta coerenza formale interna, il che comporta, da un lato, una reinterpretazione dell'oggetto che si vuole digitalizzare in termini numerici, digitali binari, i soli che il computer può trattare e comprendere; dall'altro un riesame dell'oggetto in sé, un approfondimento analitico ed ermeneutico di ciò che si vuole ipertestualizzare e delle ragioni per le quali si vuole compiere questa operazione.
Il primo aspetto non è una semplice riduzione convenzionale, come fissare i simboli per una rappresentazione cartografica, ma un'adaequatio tra la cosa (sia essa un testo, un immagine, un oggetto, un ambiente, ecc.) e il suo possibile modello, un'approssimazione, attraverso diversi gradi di complessità, a una resa adeguata dei caratteri salienti di ciò che si vuole digitalizzare. E il secondo aspetto, lungi dall'essere una mera operazione logico-informatica, è invece un fare i conti con l'oggetto nella sua globalità e nel suo contesto d'origine, un prendere contatto con la sua materialità e con il suo ruolo nell'immaginario.
La digitalizzazione è un'operazione decontestualizzante e ricontestualizzante, scompone e ricompone gli oggetti in funzione di una loro ricomprensione; ma non ha come obiettivo la sostituzione dell'oggetto, bensì la sua simulazione. E tale simulazione non è un'entità astratta, ma a sua volta un oggetto, un costrutto, un manufatto concreto che entra in relazione con altri manufatti ma soprattutto non può fare a meno di entrare in una relazione metaforica con il reale. La sua visibilità e manipolabilità è dovuta anzitutto alla sua leggibilità metaforica, alla corporeità simbolica della sua interfaccia.
Dunque questo rapporto etero-referenziale, simulatorio del digitale si esprime almeno in tre gradi di rapporto con la materialità concreta dell'oggetto che si vuole simulare: 1) codifica (simulazione di dati e strutture mediante linguaggi formali); 2) modellizzazione (simulazione dinamica dei processi mediante modelli matematici); 3) similitudine (rapporto di analogia, somiglianza, differenza, richiamo metaforico o metonimico con l'analogico). La codifica, che è un carattere specifico del digitale, può avere diversi livelli di applicazione: a livello di dato, di metadato o di istruzione; nel primo caso stabilisce una corrispondenza biunivoca tra elementi esterni ed elementi interni (a partire da corrispondenze semplici come quella tra caratteri e combinazioni di bit, o tra colori e combinazioni di bit); nel secondo caso descrive i dati (da semplici informazioni d'accompagnamento a pacchetti di dati ai linguaggi di marcatura); nel terzo caso li fa funzionare, ossia rende i dati processuali.
È chiaro dunque che da tutti questi elementi dipende la natura di un ipertesto realizzato, il suo genere, la sua funzione. E a ben guardare partendo da qui si coinvolgono aspetti assai complessi di natura culturale e filosofica, che non riguardano una singola teoria, ma la nostra concezione del mondo, del linguaggio, della memoria, la nostra, per così dire, situazione antropologica.
Ed è necessario fare anche un'altra precisazione. Come abbiamo visto anche dalle note di Landow, in un ipertesto ciò che viene di solito sottolineato è la possibilità di collegare testi ad altri testi, e anzi si ipotizza che l'ipertesto serva appunto a far sì che ogni testo si possa collegare ad altri testi. Anche qui vorrei però sostenere, proprio nello spirito del Bachtin citato da Landow, che l'intertestualità operativa che si istituisce in un ipertesto non è tanto tra "porzioni di testo", ma tra nuclei autonomi, dotati di una propria «posizione discorsiva», «responsiva». Non è assolutamente legittima questa frammentazione e parcellizzazione, che pare seguire un'infatuazione per il discreto e una sua generalizzazione abbastanza diffusa ma ingiustificata (che spinge altri a pensare che ciò che conta degli strumenti digitali sia soprattutto trovare rapidamente le occorrenze di parole). Non c'è ragione di pensare che un ipertesto non possa mantenere una sua unità di senso, una coerenza testuale, articolata e complessa, o, se si vuole, più unità di senso, magari in dialogo tra loro. Ma ciò non significa che ogni "nodo" costituisca unità a sé. Altrimenti si rischia di cadere nell'analogia falsificante tra ipertestualità e semiosi illimitata, del rimando infinito a una rete di"interpretanti" che è, a mio parere, un'interpretazione errata dell'ipertestualità. La rete infinita dei rimandi è un abuso dell'ipertestualità, e non certo il suo lato più innovativo. È un'idea che a volte è utile, un monito contro le fossilizzazioni dell'interpretazione, ma nello sviluppo della testualità digitale mi sembra sostanzialmente un cul de sac, senza vie d'uscita.
4.1 Generi ipertestuali
Sono partito provocatoriamente da una domanda: se l'ipertesto ci possa dire qualcosa sui generi letterari. Non volevo suggerire che l'ipertesto è a sua volta un "genere letterario", bensì che i modi di funzionamento dell'ipertestualità permettono di guardare dentro ai generi letterari introducendo un punto di vista architettonico.
In realtà è assai problematico intendere l'ipertesto come semplice «genere», e questa mia affermazione può sembrare anche in netta contraddizione col titolo dell'intervento di Kerstin Pilz. È vero che la parola genere, come si è visto, ha in realtà molti livelli e ampiezze, e bisogna intendersi in primo luogo sul livello di cui si sta parlando. Ma se si prendono in esame le forme concrete che sta assumendo la testualità digitale, e non l'ipertesto come metafora, bisogna porsi anche altri problemi. Quello che voglio dire è che, se l'ipertestualità è un genere, lo può essere sul piano macroscopico, dei generi terziari, o sul piano microscopico, nel senso che esistono forme differenti di ipertesti. E ciò ha una certa rilevanza per il nostro discorso. Le forme ipertestuali possono costituire generi differenti, è ciò è già visibile nel web, anche se si deve tener conto che si tratta di un'esperienza alla sua fase aurorale. E si possono già individuare tipologie di generi ipertestuali, distinguibili per funzione, contenuto e forma. Ma bisogna intendersi sui criteri usati per distinguerli.
Questo parlare dell'ipertesto un po' nebuloso e mitizzato che ha prevalso finora ha sempre sottovalutato la fenomenologia della scrittura digitale corrente, anche perché non esistevano consolidate pratiche di scrittura ipertestuale e un numero elevato di ipertesti realizzati (a parte alcuni prototipi che hanno fin troppo attirato l'attenzione); ma ora che ci si può cominciare a scollare dall'"oggetto-ipertesto" e considerare che l'ipertestualità è, quasi più banalmente, una forma di scrittura, si può constatare che essa si piega a molte esigenze e assume forme diverse. Per differenziare eventuali generi ipertestuali di solito si fa riferimento al loro ipotetico corrispettivo non digitale, ovvero a generi letterari preesistenti o a suddivisioni di mercato, o a singole discipline o a presunti settori culturali. Per esempio un manufatto digitale, in rete o su qualsiasi genere di supporto, può essere ludico, didattico, informativo; contenere testi e documenti che lo caratterizzano (un film, un romanzo, ecc.); può avere come punto di riferimento il modello dell'edizione critica, o dell'edizione commerciale; può assumere la forma di un commento, di un saggio oppure di un testo o di una raccolta di testi creativi; può occuparsi di letteratura, di arte, di scienza, di musica ecc. C'è ovviamente qualche giustificazione in questo modo di suddivisione, e non va sottovalutata. Tanto più che va considerato che il mondo digitale, oltre a piegarsi verso il mondo non digitale, acquisendone regole e classificazioni per farsi spazio, è, come si è detto, costitutivamente etero-referenziale, quindi è destinato a fagocitare e rifunzionalizzare, almeno per un lungo periodo, non solo gli oggetti della cultura non elettronica, ma anche certe sue forme e usi.
Io credo tuttavia che non siano questi i criteri più efficaci per comprendere le tipologie degli ipertesti, e che non sia nemmeno decisivo il fatto che la testualità digitale, avendo già un suo mercato, si possa impacchettare in generi commerciali, come i cd-rom del tipo "risorse", "gioco", "enciclopedia", "monografia", ecc. Penso che una differenziazione più accurata dei generi ipertestuali debba essere fondata su fattori interni: i linguaggi, la forma, la struttura, i processi che all'interno di questi ipertesti sono in atto; e naturalmente si deve tener conto degli scopi per cui sono costruiti, verificando se il loro modo di funzionamento corrisponde a tali scopi e in un certo senso li onora. Quindi si tratta di tener conto di come questi ipertesti sono concepiti, dell'idea di testo che gli autori possiedono, dei loro modelli culturali impliciti ed espliciti, ma anche proprio della programmazione, dei percorsi, dei tipi di processi che vi sono inseriti. Parlare di ipertesti implica necessariamente interrogarsi su che cosa sia l'ipertestualità, e ciò impone una certa cautela, e nello stesso tempo una certa radicalità. È una nuova modalità di scrittura e di discorso, genera testi completamente differenti da come li abbiamo concepiti per tre-quattro secoli, ma dobbiamo stare attenti alle mitizzazioni. Certo è possibile cominciare a chiedersi se ci siano elementi sottostanti, nelle modalità di scrittura ipertestuale, che possano caratterizzare un tipo di comunicazione letteraria, o che costituiscano un modello di «genere letterario» per il tempo futuro - la tentazione è sempre quella "hegeliana" di pensare che ogni epoca scelga il suo genere predominante e ne faccia il simbolo della comunicazione, e che la prossima era possa assumere l'«ipertesto» come sua bandiera - ma se si fanno queste considerazioni conviene passare prima per la fenomenologia dell'ipertestualità reale, in tutte le sue differenziazioni.
In realtà le forme dell'ipertestualità sono determinate da un insieme di modelli, di registri, di funzioni, di processi, di strutture che la costituiscono, ed eventuali "generi" possono essere individuati in base alla distribuzione e alla tipologia di questi elementi all'interno di un ipertesto, inteso come unità testuale dinamica. Particolarmente importanti sono le funzioni - che ho chiamato pragmemi - che legano zone dell'ipertesto a un numero determinato di azioni possibili. La loro presenza, assenza, densità e distribuzione determinano la natura e il funzionamento di un ipertesto prima di ogni altro elemento. Non è il caso di soffermarsi ora su questi aspetti;32 dico solo che una vocazione sicura dell'ipertestualità, anche all'esame delle singole realizzazioni, mi sembra quella critica e architettonica, e ciò conferma quanto andiamo dicendo.
4.2 Ipertesto, rete e letteratura
Dicevo che siamo agli albori della scrittura digitale, e ciò significa che in realtà l'ipertestualità e la sua interpretazione sono ancora a uno stadio elementare. Contrariamente a quanto afferma quasi tutta la letteratura sugli ipertesti, con pochissime eccezioni, un ipertesto non è affatto l'incarnazione della libertà; non c'è niente di più costrittivo di un ipertesto realizzato: l'ipertesto è una specie di violenza che si fa al testo, è una specie di riduzione coatta al testo che si ha sullo schermo, e di limitazione, paradossalmente, dei suoi possibili legami. Di questo bisogna essere consapevoli proprio perché l'ipertestualità in generale ha la caratteristica di rendere la scrittura e la testualità processuali, stratificate e multimodali, e quindi di ampliare le potenziali connessioni. Ma bisogna comprendere bene in che direzione: io non credo che ciò avvenga attraverso quel che si intende in genere per link. Una singola realizzazione ipertestuale è precisamente, sul piano del semplice link tra documenti o porzioni di documenti, una specie di incanalamento forzato, tutto diverso da come è descritto sui giornali ma anche sui libri seri che si occupano di ipertesti. Questo per molte ragioni. In generale l'aspetto costrittivo di un singolo ipertesto si può comprendere facilmente se si fa un paragone proprio con il vecchio mondo cartaceo.33 L'ipertesto traduce i collegamenti in azioni (porta fisicamente sullo schermo il testo collegato): proviamo allora a trasporre il funzionamento dell'ipertesto dallo schermo al mondo fisico. Innanzitutto c'è una limitazione nella possibilità di vedere e di maneggiare l'insieme: è come se io prendessi un libro e ne dovessi vedere soltanto una piccolissima parte, che rientra in un rettangolo bidimensionale fisso. Inoltre c'è una limitazione dei movimenti: se io voglio uscire da questa piccolissima parte visualizzata, posso percorrere solo uno stretto cunicolo, oppure un altro, ma sempre attraverso pertugi prestabiliti da altri che mi danno l'illusione del caso. Si può anche trasferire la situazione nel vecchio luogo reale di una biblioteca: lì quella operazione dello spostamento da un testo a un altro è infinitamente più lenta e complicata, ma allo stato attuale è ancora incomparabilmente più libera.
Nell'ipertesto, la libertà è relativa, dipende molto da come è costruito l'ipertesto, dalle risorse a cui dà accesso, e da cosa contiene. Anche in rete, in ogni caso, tale libertà non è data, ma va conquistata con enorme fatica, la stessa fatica che ci vuole per orientarsi in una biblioteca: paradossalmente quest'ultima è un labirinto virtuale, il mondo ipertestuale è ancora un insieme di labirinti reali. Nella biblioteca occorrono molti parametri culturali per accedere, nella rete di ipertesti sono necessari molti parametri per scegliere. Certo cambiano molte cose, ma è ora di criticare decisamente la fase "propagandistica" che ha accompagnato le nuove tecnologie e le sue dannose promesse di infinità.
Guardiamo piuttosto come è fatto un link, un bottone di collegamento, in una delle sue forme più diffuse, il linguaggio HTML del web. Il link è, secondo la letteratura corrente, uno dei cardini dell'ipertestualità: il collegamento è permesso da un'"ancora" che si presenta così: <a href="[1]">[2]</a>. Ora questo comando codificato stabilisce un collegamento unidirezionale tra una porzione del testo che io inserisco in [2] e un documento o un'altra porzione di testo, la cui collocazione io indico in [1]. Tutto quello che io faccio è inserire un riferimento (il nome del file e il suo indirizzo) a cui il testo rimanda qualora si clicchi la parola o le parole che ho messo in [2]. E questa è la semplice operazione, assolutamente univoca come vedete, per potersi spostare da una porzione di un determinato testo a una porzione di un altro testo. Cioè tutto dipende da quello che l'autore-programmatore ci mette dentro; quindi, almeno in questo tipo di link, non c'è nessuna libertà; c'è una specie di pre-percorso allestito da chi ha preparato l'ipertesto: esso stabilisce che ad una certa parola corrisponde un certo documento, e di solito le possibilità sono molto poche. Io sostengo però che i link che contano davvero, nella scrittura digitale, sono altri: quelli che collegano il testo a diversi possibili processi. Ma questi processi, in genere, nella letteratura sugli ipertesti sono del tutto trascurati sul piano teorico e analitico, o comunque non considerati unitariamente e criticamente.34 Altro fattore di confusione è non distinguere tra livelli diversi, tra il livello per esempio della programmazione e il livello dell'uso, tra la scrittura e la lettura, oppure tra l'uso e la diffusione; il già citato libro di Landow, per esempio, non stabilisce mai una differenza tra il costruire un ipertesto e il leggerlo, l'usarlo; invece ce n'è moltissima, e le due operazioni non si possono sovrapporre né sul piano teorico né su quello pratico, anche se sono entrambe potenziate e comunicanti.
Credo che l'ipertestualità abbia ancora molto da imparare dalla letteratura. Ne era consapevole uno dei "padri" dell'ipertesto, Teddy Nelson, tra l'altro inventore della parola "ipertesto". Ho qui il suo libro famoso, Literary machines, che è uscito con diversi aggiornamenti (vari "rilasci"), a partire dal 1981. Ho in mano la traduzione dell'edizione del 1990.35
Nelson si rifaceva direttamente al sistema letterario,36 come è evidente fin dal titolo, e adottava, nella disposizione della materia, un modello quasi sterniano: c'è un primo capitolo; poi ci sono alcuni secondi capitoli, una Prefazione, poi di nuovo alcuni primi capitoli, poi un secondo capitolo, e poi alcuni terzi capitoli ecc. Inoltre Nelson ricorre spesso a immagini, diagrammi e schemi; definisce il proprio lavoro non sequenziale, non lineare, e non mette i numeri di pagina (mentre l'editore italiano li ha aggiunti), per dare ancor più l'idea che si possa aprire il libro da qualsiasi parte - come del resto si può fare con qualsiasi libro, ovviamente. Anche questo atteggiamento, credo, fa parte di una fase che, pur rifacendosi esplicitamente alla letteratura, ne privilegia l'aspetto autocritico, come del resto è comprensibile. Se il vecchio medium diviene il contenuto del nuovo medium, come voleva McLuhan, è vero anche che con il digitale si esplorano e ripercorrono le ipotesi sperimentali e i confini critici del vecchio. Ma il nuovo è altra cosa, si presenta dalla porta di dietro. E credo che abbia molto a che fare con il fatto che cambia la natura della scrittura e del discorso: la prima diviene processuale e dinamica, il secondo diviene architettonico. Qui, e non nella proliferazione dei rimandi "democratici", sta, secondo me, la premessa per un cambio di civiltà.
La letteratura ha da insegnare a questo nuovo modo di scrivere e di leggere non tanto dal suo lato, per così dire, sovrastrutturale, ossia attraverso questa o quella teoria della letteratura, ma proprio come insieme, come corpus che funziona in modo polisemico, figurale e dinamico. È un patrimonio di topoi, di temi, di posizioni inconciliabili che mette alla prova sul piano tecnico e culturale le potenzialità architettoniche dei nuovi strumenti digitali. E i generi marginali, dal canto loro, mi sembra che lavorino in questa direzione dall'interno, insidiando e trasformando un modello estetico, mettendo in discussione il concetto di "opera", imponendo uno sguardo al mondo e alla realtà.
Nelson, che non è un letterato, si rifaceva alla letteratura non certo per il suo valore estetico, ma per la sapienza intertestuale e critica che essa incarna. E il suo progetto Xanadu è forse fallito proprio perché troppo ambizioso. Nelson considera il web un sottoprodotto rispetto al modello che egli si prefiggeva, e, dal suo punto di vista, non gli si può dare torto.37
Certamente si può dire che il web è pluri-lineare, cioè ha molte possibilità di percorsi, che sono peraltro già previsti localmente dagli autori-programmatori, i quali hanno posto certe possibilità, hanno assunto certi modelli, certe forme di presentazione e strutturazione. Certo, quando si accede a strumenti di ricerca analitici sui testi aumenta enormemente la possibilità di lavoro autonomo del lettore, ma anche in quel caso intervengono certe scelte di interfaccia e di software, di accessibilità e utilizzo, che influenzano le ricerche e i risultati. Come scrive Nelson, «Even a database has a point of view».38
Bisogna esserne consapevoli, perché questo è un problema cruciale che non riguarda solo gli autori di ipertesti, ma anche il nostro argomento dei generi marginali, e si può definire, in generale, il problema dell'organizzazione della pluridiscorsività. E ha anche dei risvolti importanti, come quello di trovare il modo di stabilire dei percorsi e di renderne conto al lettore, problema sterniano per eccellenza,39 problema "moderno", che nasce con la scienza sperimentale, come tensione tra ricerca e discorso, logica della scoperta e narrazione.
4.3 Strutture, registri, strategie, modelli epistemologici
Anche Nelson, tuttavia, abbraccia l'utopia della connettibilità assoluta ricorrendo a un modello astratto, quello della rete, del reticolo. Vede le nuove tecnologie come un potenziamento dell'intelligenza umana. Ma siamo sicuri che la rete sia l'unico modello esistente, e, soprattutto, che sia il più adatto? Se guardiamo la rete esistente, cioè internet, vediamo che è molto lontana da quel modello e non solo perché sta al di sotto degli obiettivi di Nelson: piuttosto che a una rete astratta somiglia a un territorio, con tutti i suoi impedimenti, costellato di città e paeselli.40 E se proprio dobbiamo estrapolare dei modelli astratti, e soltanto per il tipo di link che corrisponde al collegamento tra testi, vediamo che, oltre a quello reticolare, ne esistono molti altri. Posso mostrare almeno quelli che mi sembrano i più importanti, alcuni gerarchici, altri no: il modello ad albero, il modello circolare, il modello inclusivo, il modello a stella:
|
Sono tutte strutture di collegamento che convivono con quella reticolare e la deformano. È importante quella inclusiva perché non è riducibile a un modello reticolare, o ad altri modelli, e rappresenta, si potrebbe dire, una logica figurale differente. E ne esistono altre che possono essere considerate derivazioni o versioni particolari di questi modelli strutturali, come ad esempio il modello lineare, che può essere considerato una semplificazione del modello ad albero, salvo introdurre un fattore temporale (successione) condiviso anche (in modo differente) dal modello circolare.
Pensare che l'intelligenza aumenti trascurando la morfologia, il corpo, mi sembra un'altra illusione della fase aurorale delle neotecnologie. Il digitale va nella direzione opposta: unisce il massimo di astrattezza e rigore formale alla dimensione corporea, tattile, esperienziale. E anche per questo non si può trascurare, in un esame dell'ipertestualità, il fattore morfologico. È, come risulta evidente, una morfologia semantica, che mette in gioco stili di pensiero e concezioni del mondo. Su questo piano vanno considerate, oltre alle strutture, anche altri elementi morfologici con notevoli implicazioni culturali. Innanzitutto quelli che si potrebbero chiamare registri della scrittura ipertestuale. Credo che le distinzioni a questo livello siano destinate a scomparire, ma allo stato attuale sono ancora abbastanza nette: esistono almeno tre registri prevalenti che orientano la costruzione ipertestuale, testuale, iconico-grafico, e multimodale. La tendenza mi pare quella dell'inclusione del più semplice nel più complesso (nel senso che il testuale e l'iconico-grafico tendono a essere inclusi in cornici e ambienti multimodali). Ma più importanti sono altre due tipologie morfologiche, che chiamo le strategie e i modelli epistemologici (mi servo di nomi di comodo, suscettibili di riformulazioni più riflettute, al solo scopo di spiegare le differenze). Fondamentali per il funzionamento degli ipertesti, come si è detto, sono i processi che l'ipertesto mette in atto, e quindi le strategie che presiedono a tali processi. Le principali mi sembrano quattro: l'analitica, la sistematica, la strutturata, la casuale. La prima privilegia la ricerca di occorrenze di simboli e stringhe; la seconda (la sistematica), ordina la materia in elenchi, menu, liste di argomenti e di titoli; la terza (la strutturata), ordina la materia architettonicamente, secondo gerarchie di contenuto; la quarta (la casuale), usa la prima strategia per accedere casualmente a elementi della seconda e della terza, e credo che questa quarta strategia non sia da considerare un elemento ludico di poco conto, ma un aspetto teoreticamente assai interessante.
Dietro a queste strategie, evidentemente, stanno ben più profondi retaggi culturali che riguardano non solo la storia e lo sviluppo delle tecnologie digitali, ma la storia della conoscenza e della cultura umana. Consapevole dei difetti che le grandi semplificazioni possono comportare, vorrei tentare di indicare sinteticamente quelli che mi sembrano i retaggi più importanti. Innanzitutto distinguerei due grandi filoni epistemologici: chiamerei il primo computazionale, il secondo enciclopedico.41 Il primo, il computazionale, ha una lunghissima storia, e poggia sostanzialmente sull'idea che sia possibile trovare un linguaggio universale per intelligere il mondo. È un filone che ha grande importanza nella nascita del computer: procede con l'algebra booleiana in tempi recenti, ma risale fino a Leibniz e fino a primi tentativi di calcolo basato sul sistema binario (che usa solo due simboli, 0 e 1). Uno dei caratteri salienti di questo filone di pensiero è quella di desemantizzare completamente il calcolo: vero e falso diventano due posizioni equivalenti però diverse, opposte - e il computer attuale funziona così. È un modello algebrico, logico, algoritmico che ha un'importanza fondamentale nel mondo digitale, essendone l'ossatura. Le strategie analitiche si basano su questo modello: tutti i procedimenti di ricerca di occorrenze non potrebbero funzionare senza di esso.
Il secondo filone, l'enciclopedico, è molto più articolato, ed è ancora più difficile semplificare. Tuttavia mi sembra, ai fini del nostro discorso, che possa articolarsi in tre sottomodelli: il primo, il più recente, che chiamerei lemmatico, è molto vicino al modello computazionale. È di derivazione illuministica, e ha come suo punto focale epistemico il linguaggio, le parole: l'idea è che un ordine arbitrario (come quello alfabetico) possa garantire un accesso più efficace e più libero al sapere. Ciò influenza in parte strategie di tipo analitico (che comportano soggettazioni e uso di database), in parte la riproposizione di un cavallo di battaglia del mondo tipografico, l'indice.42 Il secondo sottomodello, che chiamerei onomasiologico, ha come punto focale epistemico le cose, il mondo; è un modello che deriva da una modernità più antica di quella illuministica, inaugurata dalla nascita delle scienze empiriche: l'idea è quella di un ordine delle cose, di una fondazione di discipline. Il terzo sottomodello, che chiamerei semasiologico, è ancora più antico, direi premoderno. Il suo focus epistemico è cosmologico, teologico: stabilisce strutturazioni semantiche di grande portata, basate su un ordine gerarchico ideale. Questi ultimi sottomodelli intervengono ancora massicciamente nella nostra cultura e altrettanto influenzano le strategie che presiedono alla presentazione dei contenuti e alla loro interattività in un ipertesto, in particolare quelle che ho chiamato strategie sistematiche e strutturate.
In questa prospettiva mi sembra che possano distinguersi due grandi categorie di testualità digitale: quella che si avvicina al tipo index (debitrice soprattutto ai modelli epistemologici computazionale e lemmatico) e quella che si avvicina al tipo thesaurus (debitrice soprattutto ai modelli sistematici e strutturati).43 Naturalmente in un singolo ipertesto, e a maggior ragione nella rete di ipertesti che è internet, convivono tutte queste forme (strutture, registri, strategie e modelli epistemologici). Credo però che aver distinto questi livelli di analisi possa aiutare non solo a distinguere tipologie o generi ipertestuali, valutando la parte che svolgono queste forme in un singolo prodotto, ma anche a leggere meglio il fenomeno dell'ipertestualità nel suo complesso.
5. Conclusioni
Tre ultime notazioni brevissime, che lascio un po' in sospeso, prima di dare la parola a Kerstin. La prima riguarda ancora la nozione di genere, e di genere terziario. Vorrei citare ancora Bachtin quando afferma che «dove c'è lo stile, là c'è il genere».44 In questa affermazione sta l'idea bachtiniana di una possibilità di storiografia letteraria e di stratigrafia sociale del testo. Bachtin si riferiva a una teoria dei generi del discorso (primari), ma l'idea che un genere del discorso sia un elemento storico condiviso che ci serve a comprendere meglio un'opera nel suo contesto stratificato è estensibile a mio parere, sul "tempo grande", ai generi terziari. E ciò permette di articolare ancor meglio una teoria dell'intertestualità nella sua storicità multipla: dietro ai testi stanno i generi, le concezioni del mondo; la dialogicità comporta una dimensione intersoggettiva ma anche una collettiva.
La seconda notazione riguarda l'apporto di una teoria dell'ipertestualità alla letteratura. Tra i molti aspetti, uno dei più importanti è la nuova concezione del testo che a mio parere l'ipertestualità introduce: un testo è un insieme di processi. Anche questa attenzione ai processi può introdurre un elemento nuovo nello studio dei generi, una sorta di pragmatica interna, attenta agli accessi e ai punti di fuga del testo, ai rapporti che esso istituisce con l'esterno, alla sua cronotopia grammaticale e teoretica.
Terza notazione, ancora sulla letteratura. L'espansione del dialogico, messa in luce dall'importanza crescente dei generi marginali e dalla presenza e dalla diffusione del genere architettonico, può far riflettere su un discrimine che attraversa la narrativa moderna, ma anche premoderna, tra la narrazione totale e la narrazione parziale. La dialogicità riduce l'aspirazione alla totalità, ne rappresenta quasi il limite etico. Ciò in qualche modo ci riconduce ancora a Bachtin, alla distinzione, non manichea e anzi per certi versi wölffliniana, tra il monologico e il polifonico. È come se oggi un'autentica polifonia non potesse più esistere, ma solo un dialogico diffuso. Ci troviamo in un'epoca in cui sul piano realistico prevalgono le narrazioni parziali, che aspirano a catturare frammenti di realtà, più che a dar vita a rappresentazioni complesse, mentre è lasciato per lo più al fantastico (e ad altri media) il compito di cercare di costruire mondi.
Lascio queste questioni come eventuali spunti per la discussione. Mi pare comunque, per concludere, che tra letteratura e mondo digitale possa esserci un reciproco, fruttuoso confronto. Si tratta in fondo di ricomprendere la nostra cultura, un compito che riguarderà le prossime generazioni. La cultura è una, non esiste un mondo digitale e un mondo letterario. E il sapere letterario, proprio per la sua collaudata competenza intertestuale e testuale, è particolarmente adatto a investirsi di alcune questioni teoriche che riguardano la testualità digitale; come, viceversa, l'ipertestualità può essere uno strumento per ricomprendere il letterario. L'evidenza che ho voluto dare alla dialogicità costitutiva che accomuna generi marginali e ipertestualità, pur con tutte le differenze, andava in questa direzione. È anche uno stimolo a considerare e a costruire la rete non come un grande guazzabuglio di informazioni, ma come un luogo intersoggettivo, dove dialogano tra loro dei testi, anche se diversi dai testi come li abbiamo sempre pensati.



Bollettino '900 - Electronic Journal of '900 Italian Literature - © 1999-2000
<http://www3.unibo.it/boll900/numeri/1999-ii/Pellizzi1.html>
Dicembre 1999, n. 2