Ilona Fried, Il convegno Volta sul teatro drammatico. Roma, 1934. Un evento culturale nell'età dei totalitarismi, Pisa, Titivillus, 2014, pp. 324, Euro 18
di Fulvia Namer






Ilona Fried è titolare della cattedra di letteratura italiana presso il Dipartimento di italianistica dell'Università Eötvös Lorànd di Budapest, specialista della letteratura e del teatro italiano del Novecento - in particolar modo del teatro di Pirandello -, e validissima insegnante. Ricercatrice infaticabile anche in periodi e in circostanze particolarmente difficili, ha sempre partecipato a colloqui internazionali e organizzato lei stessa convegni a Budapest di carattere interculturale (teatro, spettacolo, narrativa, poesia storia, sociologia…). Grazie a lei i rapporti culturali tra Italia e Ungheria si sono ampliati e approfonditi. Bastino due esempi: l'acuta analisi del successo delle commedie ungheresi negli anni Trenta in Italia, proprio alla fine del volume che prenderemo in esame, e l'analisi della funzione politica, linguistica, artistica di Fiume - città storicamente legata alla corona ungherese in seno all'impero austro-ungarico e assai trascurata dagli studi italiani sulla cultura giuliana - nel volume Fiume, città della memoria (Del Bianco, Udine, 2005). Ungherese è anche il giornalista citato all'inizio del complesso e stimolante saggio che presentiamo, consacrato al Convegno Volta del 1934. Antal Németh si esprime così al suo arrivo a Roma, quando vede:
«teste di fama mondiale e sconosciute, sentimenti estranei e temperamenti distanti - c'è un unico legame collettivo: il teatro. Sul podio presidenziale si vedono Luigi Pirandello col suo sorriso melanconico, e la voce fievole, e il fiammeggiante, ditirambico Marinetti vicini uno all'altro. In prima fila risplendono i capelli argentei di Maurice Maeterlink, più in là il serio Yeats dal volto rosso, dagli occhiali, di corporatura massiccia, il poeta mistico irlandese insignito del premio Nobel. Il signore anziano vestito con trascuratezza che è come se uscisse dalle pagine di qualche romanzo di Dickens è Gordon Craig, il più grande riformatore del teatro di oggi».
Questa straordinaria carrellata sull'inizio del convegno - in copertina è riprodotta la fotografia di autorità in orbace e di partecipanti in borghese - sintetizza la solennità della seduta inaugurale di un evento che era il risultato del lavoro diplomatico e organizzativo di funzionari e intellettuali in gerarchica e subordinata collaborazione (non priva di screzi e di dissidi). Essi erano comunque sempre controllati e diretti dall'alto da Mussolini, desideroso di conquistare il plauso mondiale, fondato sulle attività e sul prestigio degli intellettuali e degli artisti più validi, dignitosi e presentabili di cui disponesse l'Italia (fedeli sì al regime che li ha insigniti di onori, come la nomina all'Accademia d'Italia, ma non troppo platealmente ossequiosi e apprezzati all'estero) dopo le purghe, i confini, gli esili degli oppositori e prima - siamo nel 1934 - delle guerre d'Africa e di Spagna, delle sanzioni, delle leggi razziali, della più stretta e privilegiata alleanza con la Germania nazista. Ilona Fried che espone, approfondendolo in uno schema chiaro e coerente e con abbondanza di documenti, il lavoro che ha preceduto il convegno e le fasi del suo svolgimento, aveva già anticipato fin dal 2007 vari aspetti dell'argomento in molti suoi saggi pubblicati in varie riviste cartacee o on line, come per esempio in «Italogramma», la rivista on line ungherese di italianistica diretta dall'équipe di studiosi animata da lei.
Il convegno sul teatro drammatico era il quarto dei colloqui internazionali che avevano preso il nome da Alessandro Volta a cui il primo di essi, svoltosi a Como - di carattere scientifico - era stato consacrato nel 1927. Nello stesso anno si concludeva la brevissima esperienza "europea" dei «Cahiers du '900» con cui Massimo Bontempelli aveva tentato di stabilire un rapporto culturale europeo fondato sulla narrativa, evitando (dopo il primo numero) ogni allusione al fascismo. Ora, nel 1934, il rapporto con la cultura europea si fa apertamente sotto i simboli del regime, grazie alla partecipazione di molti (ma non di tutti!) gli invitati, esponenti anche delle correnti più innovative del teatro dell'epoca, maggiormente attirati dalla tradizione teatrale italiana che incuriositi dal suo assetto politico. Col beneplacito di Mussolini, erano stati contattati (oltre alle personalità citate da A. Nemeth) G.B. Shaw, F. Molnar, G. Hauptmann, P. Claudel, J. Romain , S. Zweig, M. Gorkij, F. Werfel, Antoine, Copeau, K. Stanislavskij, V. Nemirovic Dancenko, A. Tairof, V. Mejerchol'd, F. Garcia Lorca, W. Gropius.
Nella "quarta di copertina" si legge:
«Il convegno Volta sul teatro drammatico venne organizzato nel 1934 dalla Reale Accademia d'Italia, istituzione di spicco cui il regime fascista affidava il compito di rappresentare dentro e fuori i confini nazionali i meriti artistici e scientifici della rigenerata cultura italiana. Gli organizzatori vollero dimostrare l'importanza e il prestigio del teatro italiano e, in particolare, la sua capacità di reggere il confronto con altre forme di spettacolo come il cinema e lo sport. Storicamente, il convegno Volta è il punto di arrivo e il momento di sviluppo di diverse dinamiche culturali. Da un lato, l'apertura della cultura italiana alla regia europea precede il convegno stesso, mentre dall'altro, il sistema delle sovvenzioni statali promosso e giustificato dalla riunione romana finisce per promuovere le compagnie di giro e, quindi, un repertorio borghese. Lo studio del convegno può illuminare con molteplici spunti e da diversi punti di vista le conoscenze sul teatro italiano».
Una commissione diretta da Luigi Pirandello, coadiuvato da Silvio D' Amico, composta di sei membri - M. Bontempelli, F.T. Marinetti, U. Ojetti, E. Romagnoli, A. Panzini, G. Bertone - redasse il programma:
1) Condizioni presenti del teatro drammatico in confronto con altri spettacoli (cinema, opera, radio, sport);
2) Architettura dei teatri; teatro di massa, teatrini
3) Scenotecnica
4) Lo spettacolo nella vita morale dei popoli
5) Il teatro di Stato
Di particolare importanza il dibattito (animato da Bontempelli) sul teatro di massa per il quale sarebbero stati necessari edifici di grande capienza, in cui il maggior numero di spettatori avrebbe potuto assistere - così come invadeva gli stadi per le partite di calcio - a drammi inneggianti magari alla rigenerazione culturale oltre che politica dell'Italia, (in contrasto con i «teatrini» come quello - tollerato - di A.G. Bragaglia, capace, nonostante le varie censure, di presentare pièces a volte sperimentali e trasgressive a piccole élites intellettuali). Ma drammi o commedie capaci di suscitare i valori eroici e virili del fascismo non furono mai scritte da autori importanti: non crearono certo situazioni e personaggi «positivi» i maggiori drammaturghi dell'epoca, anche se «tesserati», da Pirandello a Bontempelli o a Rosso di San Secondo (anche se invitato, quest'ultimo non ebbe comunque nessuna funzione nell'organizzazione del Convegno) i quali esploravano con le loro invenzioni drammatiche universi inquieti e inquietanti, il cui carattere non è mai «borghese» in senso convenzionale. Nel 1935 sarà proibito a Bontempelli rappresentare La fame, e proprio nel 1934 La favola del figlio cambiato di Pirandello suscita le più vive proteste. D'altronde, con i suoi Miti, Pirandello già dal 1928 aveva avviato un teatro «impegnato» e non certo celebrativo. Nessuno aveva più scritto drammi comparabili alla patriottica Nave di Gabriele D'Annunzio, il grande assente del convegno (in genere egli era restio a partecipare a ogni evento pubblico: nel 1937, eletto suo malgrado a capo della Regia Accademia, non restò in carica più di un anno) di cui comunque fu deciso di rappresentare per i convegnisti e gli invitati, La figlia di Iorio. La regia fu affidata a Luigi Pirandello (forse per promuovere un ravvicinamento tra i due scrittori) e a questo proposito, Ilona Fried racconta (e non è l'unico aneddoto del libro) con brio e indubbio «umorismo» i patetici tentativi del grande scrittore non solo per far interpretare la parte di Mila a Marta Abba , ma per coinvolgere nello spettacolo (retribuendoli) anche suo padre Pompeo e sua sorella Cele.
 |
Nell'ultima parte del libro ci sono le riproduzioni a colori dei bozzetti e dei costumi (assai banali) della rappresentazione ad opera di Giorgio de Chirico, come pure (oltre all'affiche del convegno e a riproduzioni di moltissimi manoscritti) le fotografie di alcuni dei convegnisti italiani e stranieri. E nella conclusione, Ilona Fried sottolinea il carattere eccezionale, nel 1934, di un raduno di tante personalità che nel giro di pochi anni sarebbero scomparse, sia per vecchiaia o malattia, sia - soprattutto - per le persecuzioni naziste e staliniste.
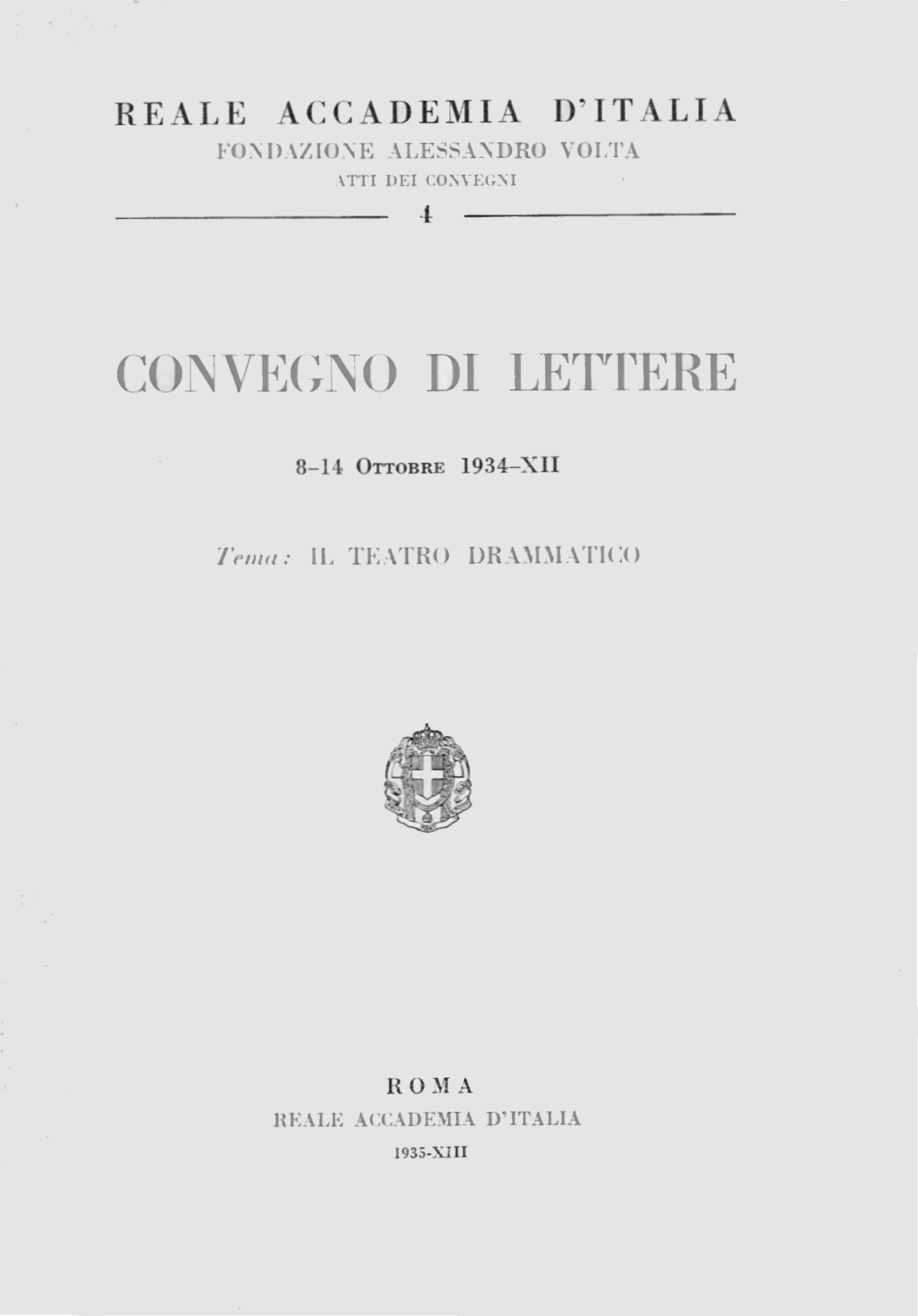 |
Si tratta di avvenimenti, trattative, manovre più o meno sotterranee, giochi di potere che Ilona Fried ha potuto studiare consultando documenti, archivi, fondi pubblici o privati, istituzioni, corrispondenze raccogliendo testi manoscritti, stampati, dattiloscritti, documenti grafici, disegni fotografie. E Il convegno Volta sul teatro drammatico, Roma 1934, che è il primo saggio monografico sull'argomento, si inserisce a giusto titolo tra le opere consacrate alle istituzioni culturali del ventennio fascista.






Bollettino '900 - Electronic Journal of '900 Italian Literature - © 2014
<http://www3.unibo.it/boll900/numeri/2014-i/Namer.html>
Giugno-dicembre 2014, n. 1-2